COSTRETTI A SANGUINARE
MARCO PHILOPAT
AGENZIA X
Quella che abbiamo finalmente tra le mani è la nuova edizione aggiornata di “Costretti a sanguinare”. Duecentosessantasei pagine riviste e revisionate, sia nel testo che nella parte grafica totalmente improntata sui lavori del compianto prof. Bad Trip. Del testo originale è stato mantenuto lo stile accattivante e dinamico che scandisce in modo ritmico e serrato l’esperienza personale di Marco Philopat nella Milano occupata degli anni settanta ottanta. Dagli stabili occupati abusivamente per chi lasciava la famiglia e cercava una sua dimensione sociopolitica alla nascita dei primi centri sociali negli anni ottanta. Inizia qui la storia di Philopat e del movimento punk italiano e va avanti fino al decennio seguente, tra scontri [sia di piazza che interni al movimento], slogan, birre, droga, repressione, ingenuità e tutto quello che ha caratterizzato quegli anni turbolenti in cui qualcuno ha davvero creduto [e sperato] di riuscire a cambiare il mondo.
Ci sono un sacco di passaggi del libro che delineano gli scenari e le sensazioni che hanno pervaso queste realtà ai margini. Riportarli tutti alla lunga stonerebbe e sarebbe fuori contesto, per cui ci limitiamo a soffermarci su quelli a nostro avviso più significativi. Non possiamo non partire dalla sentenza che sin dalle prime pagine chiarisce come già allora fossimo un passo indietro al resto del mondo, nonostante si pensasse [e spesso si pensa tuttora] di essere all’avanguardia. “in italia di punk c’è ben poco, ogni cosa arriva in ritardo di anni diventando patetica e provinciale”.
Potremmo fermarci qui. Salvare il file e spegnere il pc. In queste poche parole c’è tutto quello che serve per inquadrare il movimento. Se forse al tempo l’affermazione era provocatoria negli anni a seguire si realizza la sua vera consacrazione. Soprattutto per il nostro piccolo mondo quotidiano. DR mi ha sempre fatto riflettere su una cosa [e su questo gli ho sempre dato ragione in toto]. Nel 1997 a Spezia si inneggiava nei concerti a suon di Gabba Gabba Hey e si scopriva il punk mentre nel resto del mondo il Grunge ribaltava le prospettive dando vita alla terza ondata punk, quella degli anni novanta [la seconda quella degli ottanta era stata quella del Grindcore]. Eravamo in ritardo di ventanni rispetto al resto del pianeta e pensavamo, anzi pensavano visto che io ero uno dei reduci dell’ondata Grindcore del decennio precedente non fosse altro che per ragioni anagrafiche, di essere parte di un movimento che in realtà si era estinto due decenni prima. Una tristezza epocale, patetica e provinciale come giustamente ha scritto Philopat.
Da qui alla provocazione ulteriore [anche perchè il punk privato della sua componente provocatoria è praticamente nullo, diventa mainstream] del “il punk non è mai morto perchè per fortuna il movimento punk non è mai nato” è un attimo, un battito d’ali o poco più.
Certo oltre la vena provocatoria c’era [e non poteva essere altrimenti] una forte componente attitudinale, ma resta il fatto che il compiacersi nel “no future” era uno dei cardini intorno al quale ruotava tutto. Ci piace sottolineare come sin da subito anche i più sfigati videro nel movimento il loro modo di emergere da una vita priva di soddisfazioni. Si moltiplicarono i figli di papà che grazie alle finanze illimitate del proprio casato potevano permettersi di soggiornare settimanalmente a Londra e reperire tutti i dischi che qui arrivavano in pochissime copie [quando arrivavano] per poterli sfoggiare nella villetta in Brianza davanti agli amici che vedevano Londra come un sogno difficilmente raggiungibile. Qui torna il discorso sull’attitudine che si scontra con la moda che fiuta il terreno fertile rappresentato dal movimento punk, inizialmente relegato a fenomeno di folclore. La cosa che più risulta degradante, avendola subita sulla nostra pelle anche in tempi recenti è il grossolano errore che individua nei punk nichilisti “vestiti di nero con borchie” i nuovi fascisti metropolitani. Come dire, se non sei come me o come vorrei che tu fossi allora sei un fascista. Sorvoliamo su ulteriori approfondimenti in merito, se non altro per non scendere al livello di chi ancora crede che questo sia lo strumento migliore per discriminare che cosa sia giusto [noi] da che cosa sia sbagliato [voi].
Per fortuna Philopat racconta come stavano veramente le cose al di là delle censure degli anni a seguire: “coi compagni ogni rapporto è pressochè impossibile, al sabato non si cono più gli scontri con la madama e allora se la prendono con noi, nel migliore dei casi ci sfottono, nel peggiore ci prendono per fascisti e allora c’è solo da scappare”. Lasciamo quindi alla vostra intelligenza ogni commento. Mentre noi ci spostiamo su un versante che riveste una sostanziale importanza a livello sociologico, dal momento che entrano in gioco le periferie, con tutte le difficoltà annesse al ritrovarsi a nascere e crescere in palazzoni di cemento armato privi di ogni servizio anche il più indispensabile. I primi punk sono originari proprio elle periferie e figli del degrado famigliare e logistico. La loro ribellione nasce proprio nel momento in cui realizzano di non avere futuro tra i palazzoni delle strade che si allontanano da Milano, “no future” appunto. La loro è una scelta tra farsi la cresta e farsi in vena. Purtroppo spesso le due cose coincisero. “nella mia zona c’erano solo l’oratorio e l’eroina nonostante la famiglia pseudocattolica in via stabilizzazione economica”. Si evince facilmente come non ci fossero grosse alternative alla fuga nelle droghe [di qualunque tipo] soprattutto per i meno fortunati.
L’iniziazione alla droga leggendo le pagine del libro pare essere già parte delle loro vite sin dal momento in cui sono venuti al mondo. Per fortuna Philopat pare aver scampato la cosa grazie al suo prolungato soggiorno londinese altrimenti non saremo qui a raccontarci tutto questo. La loro era una generazione morta in partenza, che non aveva più niente da perdere, facile cadere se sei già lanciato verso il fondo. Il mondo sta cambiando e “in molti tra quelli che sono interessati a cambiare aria vedono in noi punk la via d’uscita, la gente molla i circoli, ci sono scazzi per la scelta della lotta armata, per l’eroina e per gli arresti”. Si perdono insomma le certezze granitiche figlie di un’ortodossia filocomunista e si assiste ad uno sfaldamento del movimento politico con le forze dell’ordine che reagiscono dopo anni difficili prendendosi libertà in odore di regime forti della nullità politica che si sta affermando sostituendosi al movimento. Chi può torna a Londra dove niente sembra essere cambiato, anche perchè la capitale britannica “alla fine degli anni settanta è la città dove ogni esperienza underground diventa un segnale, un faro per il resto del mondo, c’è una produzione pazzesca di modelli diversificati di vita e ogni tendenza di strada si trasforma in una moda e le controculture si mischiano”. Anche qui noi sfigati di provincia arriviamo con un ritardo abissale, per non dire ridicolo, coi nostri coetanei che, figli di una ribellione che non esiste e non può esistere perchè non c’è nulla contro cui ribellarsi negli anni novanta, emigrano a Londra scimmiottando i nostri predecessori. Peccato che [oltre appunto alla ribellione verso il nulla] nessuno ancora mi abbia spiegato che cosa ci fosse di punk nel 1994 [dieci anni dopo l’orwelliano 1984 vero spartiacque del movimento punk italiano] nel lasciare Spezia per andare a lavorare al McDonald a Londra. Ancora non abbiamo trovato risposte in merito, se qualcuno tra voi che state leggendo vuole venirci in contro e farci partecipi della “verità” gli saremmo eternamente grati. È proprio in questi anni che abbiamo iniziato ad odiare la perfida albione e tutto quello che per noi ha rappresentato, vale a dire l’ultimo rifugio degli sfigati, il cimitero degli elefanti per tutti quelli che non avevano voglia di fare un cazzo e, magari sovvenzionati dai soldi di mammina che arrivavano via vaglia postale, giocavano a fare gli alternativi. Chiusa questa parentesi [auto]biografica torniamo alle pagine del libro, che non smettono di sollecitare i nostri pensieri riga dopo riga. Insieme alle prime fanzine fatte coi ritagli di giornale [l’archetipo del copia incolla odierno] nascono anche i primi gruppi musicali. Figli anch’essi dei retaggi imposti dall’esterno, con le paranoie sulla scelta del nome e della lingua da usare in modo da evitare richiami autarchici al ventennio ma al tempo stesso con la voglia di non scimmiottare gli inglesi. Per cui spesso chi canta in inglese si ritrova a dover [o voler questo non è del tutto chiaro] tradurre i testi in italiano e a leggerli prima del concerto in modo da dissipare ogni dubbio su ammiccamenti fascitoidi.
Da qui al passo degli autoriduttori è un attimo e si assiste troppo spesso a concerti interrotti per dare vita ad interminabili assemblee con cui stabilire se un termine era corretto da un punto di vista sociopoliticoesistenziale oppure se si dovesse imporre una censure con conseguente allontanamento del gruppo dal palco. Eravamo al punto che si faceva un’assemblea anche per decidere chi avebbe partecipato all’assemblea stessa. Una retorica soffocante che ha allontanato dal movimento politico tutti coloro che non si riconoscevano in questo stucchevole modo di ragionare consegnandolo di fatto nelle mani dell’eroina che ha avuto in quei momenti il suo massimo fulgore e la sua più capillare diffusione. Restando in argomenti più strettamente musicali un altro elemento che capta l’attenzione dell’autore e che viene riproposto spesso è quello riguardante l’estetica del punk in quegli anni, a cui è dedicato il primo capitolo, in cui viene presentato un vademecum su come vestirsi, agghindarsi e pettinarsi per potersi effettivamente sentire punk a tutti gli effetti. Il tutto ovviamente con una buona dose di autoironia, lo specifichiamo anche se non ce ne sarebbe bisogno. In ogni caso l’essenza punk passava veramente attraverso un riconoscimento anche “esteriore” cui non era possibile sottrarsi. L’alternatività era riconosciuta a partire da come uno si poneva [spesso con quel poco che aveva, tra soluzioni arrabattate e riciclo di vecchi indumenti] solo dopo, in seconda battuta si poteva passare ad un’alternativa che fosse soprattutto di pensiero e non foriera dell’ultima moda. Qui interviene ancora Philopat sottolineando come “quando potranno farci diventare un prodotto lo faranno e anche lo schifo si potrà vendere”, a ribadire come le mode [e chi di moda campa] siano [e fossero] sempre pronte a sfruttare il mood del momento. E se di mode vogliamo parlare un passaggio interessante è quello dedicato ai Dark.
Partendo dal presupposto che il movimento giovanile “it’s not fashion” agli occhi dei punk “i dark sono nostri compagni e invece li trattiamo come regolari”. Si cercava di essere più alternativi degli alternativi [io sono punk più di te, concetto che su altre basi e in altri campi non ha mai abbandonato un certo modo di fare politica] e invece non si capiva come i lugubri darkettoni altro non fossero che ragazzi che come loro cercavano di comunicare la morte della società, facedolo con un diverso approccio e una differente estetica. La parentela c’era ed era piuttosto stretta, peccato non la si sia voluta vedere. Un elemento di transizione che ha sancito una prima e decisiva spaccatura del fenomeno politico di quegli anni è stata la morte di Aldo Moro, vissuta da buona parte dei ragazzi delle periferie degradate come la fine di un sogno [forse mai davvero iniziato per alcuni di loro]. Trauma che li ha allontanati dalla lotta politica in prima persona per catapultarli diretti e senza difese in pasto all’eroina. Viene a mancare la spinta sociopolitica che il movimento punk associato a quello giovanile universitario in particolare hanno messo nel proprio motore come propulsore per la lotta al sistema. La socialità si sfilaccia e si inizia a vivere in funzione della dose da procurarsi. Si perdono i contatti, la stima e le amicizie e si inizia a vivere come morti in attesa del proprio funerale.
Contemporaneamente i figli di papà hanno dimesso l’eskimo e la lotta politica per tornare a scuola dai loro professori, membri di quella destra che fino al giorno prima avrebbero messo al muro. La ricreazione è finita, tutti in classe. Il tutto mentre i “figli di nessuno” muoiono copiosamente di overdose tra l’indifferenza generale. “i tempi dei bisogni dei proletari, della rivoluzione dietro l’angolo, sono finiti da un pezzo, la capacità di recupero del sistema ha avuto ragione di ogni forma di ribellione, la tua rabbia è messa al servizio dell’industria discografica o del negozio di abbigliamento all’angolo”. Tutto sta decisamente andando nelle direzione contraria a quella che si voleva prendere. I ribelli, quelli veri sono stufi di vivere la loro frustrazione come fosse una moda e si ripropone l’eterno ed incompiuto dilemma della diatriba tra provocazione e reale attitudine.
Un sussulto di orgoglio si ha per la discesa in Italia dei Clash a Bologna, il primo giugno del 1980 in piazza Maggiore. Memorabile lo striscione di contestazione “Punk is Crass not Clash” con cui gli antagonisti bolognesi [tra cui l’amica del Tritacarne Helena Velena] accolsero e contestarono Joe Strummer e compagnia rei di aver firmato per una major mentre continuano a rivendicare una verginità militante punk e di suonare per conto del comune di Bologna e quindi per le istituzioni. Sta di fatto che questo episodio diventa uno spartiacque andando a determinare una radicalizzazione della scena punk italiana, una sorta di seconda ondata più fortemente politicizzata rispetto alla prima forse più “ruspante”.
Mentre succede tutto questo, ma non solo, a Milano Philopat e gli altri occupanti degli alloggi di via Correggio danno vita al primo centro sociale della città, il Virus che diventerà il principale punto di riferimento per chiunque facesse o ascoltasse musica in quegli anni. Con tutti i suoi difetti e le sue problematiche il Virus resiste alle pressioni istituzionali esterne e si innalza a livelli europei ospitando serate di livello internazionale e diventando una realtà consolidata. Non c’è una serata che non registri il sold out. Le cose prendono forma e si concretizzano quasi magicamente fino alla chiusura del 1984, data non casuale se si ripensa ai riferimenti orwelliani di un certo tipo di pensiero. Il 1984 dunque, il punto di svolta tanto atteso è finalmente arrivato. Purtroppo però dietro l’angolo non c’è il nuovo mondo ma il peggiore degli incubi. Il Virus viene chiuso e con lui spariscono le speranze sotterrate dalla “Milano da bere” che incombe con il suo carico di cocaina, modelle facili e imbonitori televisivi pronti a venderti nuovi sogni confezionati per l’occasione. Viene a mancare un cambio di mentalità e di obiettivi e la reazione tarda ad arrivare. Il fuoco della rivolta si spegne e tra le ceneri restano i rimpianti di chi ha investito la propria vita tra le mura del Virus. Il libro non è tutto qui, in quello che vi abbiamo raccontato. Ci sono tante sfuamture che non vogliamo svelarvi.
Possiamo solo dire che non si tratta di un romanzo vero e proprio così come non è possibile assimilarlo ad un saggio. È e dovrebbe a nostro avviso essere visto /letto/diffuso come un racconto [“urlato” come dice lo spesso Philopat nel sottotitolo] in cui tra episodi reali di vita vissuta dell’autore si innestano elementi di un’eco collettiva. Si potrebbe inquadrare quindi riprendo ancora una volta le parole di chi lo ha scritto come “un lavoro di ricerca, un intreccio tra memoria e scrittura, non un lavoro di invenzione quindi ma una sedimentazione di ricordi conseguente ad un accurata elaborazione di fatti tratti da materiali di archivio e di testimonianze dirette”. Sostanzialmente, per concludere, ciò che emerge dal racconto di Philopat è una realtà talmente lontana dai nostri giorni che molti faranno fatica anche solo ad immaginare, sono stati anni crudi e spietati che difficilmente torneranno, anni descritti alla perfezione da uno che li ha vissuti in prima persona, “da dentro” e che ha pagato lo scotto di una ribellione verso una società subito pronta a condannare il “diverso” additandolo come feccia e relegandolo all’emarginazione non solo sociale. Se a ciò aggiungiamo quella vena autoghettizzante figlia di una “superiorità” non dichiarata ma sentita e condivisa da parte dei “ribelli” rispetto al resto del mondo si spiega molto facilmente come nonostante tutte le buone intenzioni spesso si sia faticato oltre il dovuto per coinvolgere la “gente normale” nelle iniziative sociopolitiche degli spazi occupati. C’è sempre stato, magari silente e sottotaciuto per non incorrere in accuse di classismo, il pensiero se nonn la convinzione da parte di chi stava “dentro” a certe situazioni di essere nel giusto. Era colpa dei qualunquisti e dei “normali” se le cose non prendevano la giusta piega, erano loro a non capire. Eppure era tutto così chiaro. Ora a distana di anni si può anzi si deve fare autocritica e magari [senza vergogna, perchè nessuno è scevro da errori sopratutto di valutazione] ammettere che in fondo faceva in parte comodo sentirsi [ed essere] isolati, in modo da usarlo come parziale giustificazione per gli insuccessi. In realtà credo [e qui parlo per la mia esperienza di autogestione] che fosse difficile andare oltre quello che si è fatto. Se la società non ha risposto alle nostre sollecitazioni probabilmente non siamo riusciti a individuare i tasti da toccare per sensibilizzarla ed avvicinarla ai nostri sogni di uguaglianza.
Io ho vissuto la secondo ondata, quella di fine anni ottanta ed inizio novanta, quella dove l’aspetto sociale era meno forte e sentito rispetto ad un decennio prima in cui lo scontro di classe aveva assunto proporzioni maggiori. Noi ci siamo affacciati su un mondo che stava cambiando ma non siamo stati capaci di capire che parlavamo un linguaggio ormai obsoleto. Andavamo verso un mondo che si proiettava nel futuro mentre noi restavamo ancorati a modelli comportamentali superati. Magari giustissimi ma che non facevano presa sui nostri coetanei. E così, fortificandoci nell’idea isolazionistica di essere dalla parte giusta abbiamo chiuso ancora di più gli occhi finendo per decretare la fine di un’utopia che è durata lo spazio di un istante e nulla più. Ora forse ragioniamo troppo in modo negativo e non ricordiamo i momenti belli [che sono stati tanti, tantissimi, in pratica la stragrande maggioranza] e vediamo il nostro ragionamento condizionato dal finale delle nostre esperienze. Come dire, abbiamo giocato bene ma abbiamo perso.
È profondamente sbagliato farsi condizionare dall’esito finale di un’esperienza perchè la priva di ogni suo significato, spersonalizzandola ma oggi con gli anni sulle spalle che iniziano ad essere troppi e troppo farticosi da portare non siamo più così entusiasti e speranzosi come a ventanni.










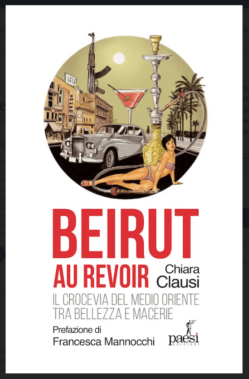

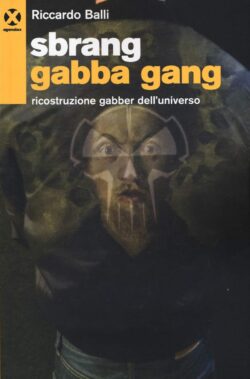

Una risposta
Bella recensione e anche un ottimo punto di vista.ritornando indietro di 30 anni più il punk mi ha fatto fare qualcosa, da iniziare a suonare e interessarmi a vari argomenti come tante testimonianze riportate.. ciao Marco