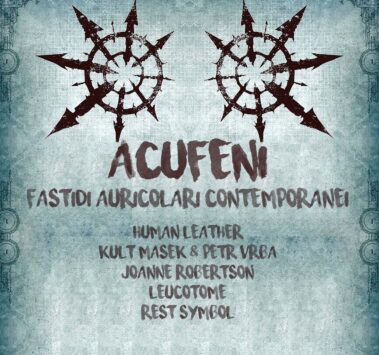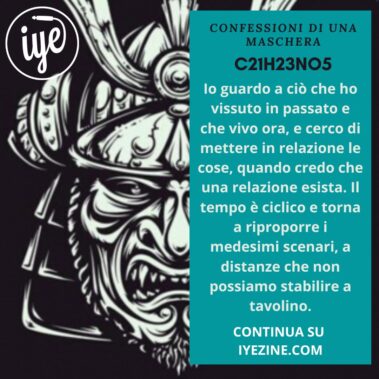Falling Leaves – The Silence That Binds Us
I Falling Leaves arrivano da Amman (Giordania), dove hanno iniziato a consolidarsi come band nel 2009. Impiegano tre anni per arrivare al debutto con “Mournful Cry of a Dying Sun”. Da allora il vuoto. Quando pensavamo fossero morti e sepolti eccoli tornare con questo “The Silence That Binds Us” titolo che spiega molto di questa loro assenza. Intanto pare che ora siano di stanza a Dubai, negli Emirati, scelta che comprendiamo fino a un certo punto.
Ma andiamo oltre e parliamo del disco. Sostanzialmente sono gli stessi di sempre, il che, in un certo ambito metal non è che sia da considerare come un appunto negativo. Si richiamano a quel lato più melodico del doom death metal che si apre a soluzioni ragionate, non eccessivamente incalzanti, quello che anche noi un tempo eravamo soliti apprezzare, ma con cui ora flirtiamo solo di rado. Al netto di tutto questo il disco suona esattamente come deve. Maestosamente malinconico, l’album guarda alle emozioni più nascoste, quelle che fino ad ora abbiamo tenuto solo per noi stessi, e che abbiamo deciso di lasciar uscire, in nome di una trasparenza che non potevamo più rimandare.
Un album doverosamente cupo, che sfocia nella depressione sonora, ma senza eccessi, cercando di non perdere il contatto con il pathos e l’emotività, in un vortice di soluzioni che aprono mondi impensabili in cui lasciarsi intrappolare.
“The Silence That Binds Us” è un album interessante che non aggiunge nulla alla storia di un genere che continua ad affascinare proprio per il fatto di non cambiare di un millimetro il proprio standard. Dopo tredici anni di attesa ci saremmo aspettati qualcosa di più ma, sostanzialmente, va bene anche così. Intanto sono tornati, per il futuro vedremo.
Farah Kaddour & Marwan Tohme – Ghazel
Farah Kaddour e Marwan Tohme sono due artisti libanesi, entrambi appartenenti al collettivo sperimentale SANAM, con cui stanno per pubblicare il nuovo album “Sametou Sawtan” di cui parleremo prossimamente. Qui li troviamo alle prese con un loro progetto parallelo, in cui si cimentano con l’avanguardia mescolata alla musica tradizionale mediorientale, libanese nello specifico.
Passano quindi da un approccio più orientato verso sonorità rock, a rivelare tutta quella bellezza intimista del loro paese di origine. Costruito – e non poteva essere altrimenti – intorno e grazie agli strumenti tradizionali arabi “Ghazel” è un album acustico che emana calore sin dalle primissime note. Un album minimale, ma proprio per questo ancor più accogliente, che scorre fluido, delicatamente, incollandoci all’ascolto. Il loro è un linguaggio musicale che non può lasciare indifferenti, e che si perde nello spazio infinito di una notte senza luna. Un suono improvvisato che cattura l’essenza stessa del calore con cui nasce e si diffonde nell’aria.
Ancora una volta, la Ruptured Records riesce a scovare una gemma da mostrare orgogliosamente. “Ghazel” è infatti un momento catartico che consigliamo a tutti coloro che hanno necessità di rivedere le priorità della vita, e che troppo spesso lasciano che la musica gli scivoli addosso. Ci sono dischi che, come questo di Farah Kaddour e Marwan Tohme, vanno assaporati e centellinati con la massima attenzione e il massimo rispetto.
Quello che il duo libanese ci ha donato non è un album ma un invito a seguirli nella difficile ricerca della bellezza, attraverso un viaggio meditativo che possa permetterci di aprirci a tutto ciò che finora abbiamo ignorato.
Ljungblut – Vietnam
Ljungblut è il progetto solista di Kim Ljung (bassista di Seigmen e Zeromancer). L’album, l’ennesimo del suo percorso, segue da un punto di vista strettamente sonoro, il precedente “Sauda” uscito un paio di anni fa, sempre su Karisma Records. Lo scenario fatto di calore e introspezione acustica è quindi quello a cui ci sentiamo di accostare in modo forse (o per lo meno per il momento) in modo definitivo per quello che, se era partito come progetto parallelo, oggi possiamo considerare come una band a tutti gli effetti.
Concettualmente ispirato dai viaggi compiuti in giovane età insieme all’amico e scrittore Harald Rosenløw Eeg, l’album è da vedere come un insieme di istantanee che riportino alla mente i paesaggi che si sono aperti ai loro occhi, e che i Ljungblut, adesso, cercano di rendere reali. In questo caso parliamo del Sud Est Asiatico e del Vietnam in particolare.
Ci sono i ricordi di viaggio che si mescolano tra loro, creando lo spazio per le melodie di Ljung, accompagnato qui dalla figlia di Rosenløw alla voce, per una simbiosi artistica che ricalca quella che lega i due al di là e ben oltre i viaggi. A quanto è dato sapere “Vietnam” è il secondo passo di una trilogia che dovrebbe racchiudere tutto quel mondo intimo di Ljung che ruota intorno ai ricordi dei luoghi della sua giovinezza, iniziato con quel “Sauda” che faceva riferimento al piccolo villaggio nei fiordi norvegesi dove Ljung ha trascorso l’infanzia.
Chitarra acustica, field recordings, pianoforte e poco altro. Non serve avere un arsenale infinito per realizzare un album di qualità, contano le idee, e di quelle Ljung sembra averne parecchie.
Träume – Wrzask
Il quartetto polacco dei Träume arriva al debutto su disco, e lo fa con un album che, a partire dal titolo (wrzask è traducibile con urlo) mette immediatamente le cose in chiaro. Nessuno spazio alla superficialità, alla bellezza, al mondo moderno e a tutta la plastica di cui è costruito. Solo un sano hardcore punk orientato verso scelte stilistiche che rimandano a quegli anni ottanta, che da loro, nella ex Cortina di Ferro, probabilmente (e mi sento di aggiungere fortunatamente) non sono ancora conclusi.
È questo che viene da pensare nel momento in cui si susseguono, senza sosta, incessantemente gli otto brani (per una durata che supera di poco il quarto d’ora) istericamente lanciati nell’etere dalla britannica Quality Control HQ. Una band che, come detto, sembra uscita dal passato (affermazione da cogliere e contestualizzare come uno dei massimi complimenti possibili, soprattutto se rapportiamo i Träume alle realtà odierne tutte patinate, ma altrettanto tutte o quasi innocue, prive di quel carico di genuinità che forse, solo in realtà come quelle delle lande al di là dell’ex cortina di ferro possiamo continuare a trovare) e che al passato guarda con un disco nervoso, schizoide, pulsante e intenso, come da tradizione hardcore punk.
L’album, cantato interamente in polacco (altro punto a loro favore) permette alla band di sfogare tutte le proprie frustrazioni ma mai senza lasciarsi andare “oltre”, c’è sempre un disegno di base a cui fare riferimento e da cui non distaccarsi troppo, restando ancorati a quell’idea di ribellione, di grinta e di comunità DIY che fa dell’energia grezza, del sound sporco e dell’orgoglio i propri punti cardine da difendere ad ogni costo.
Tristwch Y Fenywod – Tristwch Y Fenywod
La traduzione letterale di Tristwch Y Fenywod dal gallese è “tristezza delle donne”. Spesso dalla scelta del nome si capisce immediatamente, talvolta ancor prima di aver ascoltato qualcosa, dove andremo a parare. Non fa eccezione questo debut album del trio britannico (Leeds) composto da Gwretsien Ferch Lisbeth (Guttersnipe, The Ephemeron Loop), Leila Lygad (Hawthonn) e Sidni Sarffwraig (Slaylor Moon, The Courtneys).
Sapevamo che avremmo avuto a che fare con un qualcosa di ancestrale e così è stato, anche se non ci saremmo aspettati un impatto di questo tipo. L’album è infatti una vera e propria sorpresa in quell’ambito carico di magia che accomuna il folk gotico, la musica tradizionale e il paganesimo. Marziale, ma mai troppo rigidamente rigoroso, affascinantemente costruito intorno a strumenti classici britannici, e cantato in gallese “Tristwch Y Fenywod” riesce a catturare l’attenzione sin dalle primissime battute. Un viaggio catartico, ai limiti del misticismo, in mondi incontaminati, dove la natura regna sovrana, e si respira l’eco di un passato dimenticato.
Un viaggio in cui il trio ci parla di neurodivergenza, di queerness, e di tutto quello che viene usato per mettere all’angolo chi non rispetta i canoni e gli standard sociali attuali. Un disco che guarda a quel passato e a quelle tradizioni che la politica attuale neocolonialista, nazionalista e capitalista ha distrutto, e lo fa proprio grazie agli strumenti classici, via più naturale (e per certi versi obbligata) per provare a ricostruire quello che c’era un tempo in queste terre. “Tristwch Y Fenywod” è un album che trasmette tristezza, ma anche speranza.
Un album caratterizzato da un fascino ancestrale, senza tempo, che cerca di riconciliarci con quella natura che abbiamo distrutto, con quelle tradizioni che abbiamo dimenticato, con quel rispetto della vita altrui che non abbiamo forse nemmeno mai conosciuto. Un album per chi sente giunto il momento di chiedere scusa.
TUTTE LE PUNTATE DI ACUFENI :: FASTIDI AURICOLARI CONTEMPORANEI