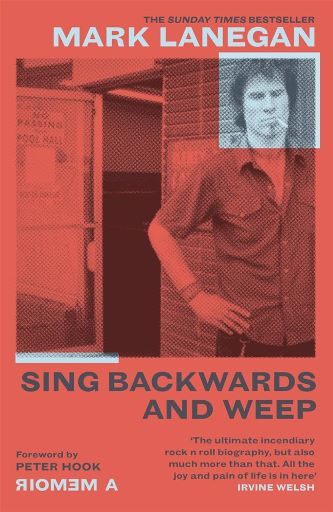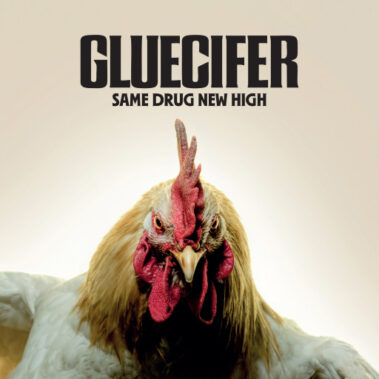Un libro, ricevuto in dono come regalo natalizio – in lingua originale inglese – che il vostro Reverendo ha avidamente e curiosamente divorato nel giro di poche settimane.
“Sing backwards and deep” è il chiacchierato e discusso memoir (che prende il titolo dai versi di una canzone dello stesso autore) pubblicato nel 2020, in cui il compianto cantante/cantautore statunitense Mark Lanegan ha raccontato, senza ipocrisia e in modo franco e spietato, la tormentata parabola di gran parte della propria esistenza personale e musicale in 43 capitoli che si interrompono, cronologicamente, nel 2002, e che oggi sappiamo essersi poi protratta per un altro ventennio, purtroppo stroncata nel 2022, quando il nostro ha lasciato questo mondo, a 57 anni, a causa dei postumi del covid-19.
Lanegan, che da questa autobiografia – dedicata ad Anthony Bourdain, che ne aveva ispirato la genesi, e ad altri suoi amici scomparsi – aveva tratto ispirazione, anche sonoramente, per realizzare uno studio album, “Straight songs of sorrow” (di fatto, il suo ultimo lavoro solista) si discostava decisamente dai canoni e dai cliché delle classiche rock bio (spesso autocelebrative, autoreferenziali, autoindulgenti, “ripulite” e romanzate-edulcorate) scegliendo uno stile diretto e in prima persona, a tratti brutale, cruda e burbera, per offrire un ritratto (il più schietto possibile) degli avvenimenti accaduti in trentasette anni (fino alla chiusura cronologica del volume) di una vita violenta, e la citazione Pasoliniana calza a pennello, in quanto “Dark Mark” avrebbe potuto facilmente essere paragonato a un soggetto delle borgate degradate descritto nei romanzi-film del geniale intellettuale friulano.
O, ancora meglio (o peggio), a uno dei personaggi del cult movie “Amore Tossico” di Claudio Caligari (che, in fondo, del cinema di Pasolini ne è stato a suo modo erede e prosecutore).
Sviscerando le trecento pagine di “Sing backwards and weep”, salta subito all’occhio un dato di fatto inoppugnabile: Mark Lanegan non faceva sconti a nessuno, in primis a egli stesso: non c’era spazio per autocompiacimenti nello scandagliare eventuali bravate da “rockstar” (uno status symbol, invero, sempre ripudiato dal musicista, fortemente intriso di etica punk antidivistica, ma erroneamente considerato, da molte persone, solo un emulo di Jim Morrison nel canto e, soprattutto, negli eccessi) ma trovava posto una lucida analisi di fatti e situazioni, utilizzando una formula di scrittura semplice, in brevi racconti, che scorre via veloce, asciutta e lineare, non di rado ricorrendo a un linguaggio rude e scurrile alla Bukowski (anche se la vera illuminazione letteraria di Lanegan, in gioventù, fu leggere William Burroughs).
Quel che viene fuori è il ritratto di una persona di umile estrazione sociale, discendente da lontane origini familiari irlandesi e britanniche, ribelle e refrattaria all’autorità già dall’adolescenza, protagonista di una giovinezza turbolenta (tra il divorzio dei genitori in una famiglia disfunzionale, vandalismo, furti, arresti, il sogno infranto di diventare un giocatore di baseball e i primi problemi con alcool e droghe leggere) cresciuta nel contesto agricolo-rurale redneck della piccola cittadina di Ellensburg (nello stato di Washington) bersagliato dalla mentalità locale chiusa e retrograda che non vedeva di buon occhio un ragazzo coi capelli lunghi e i tatuaggi (fu infatti vittima di bullismo) che nella musica e nel rock ‘n’ roll trovò la sua vera ragione di vita, la sua salvezza spirituale e una speranza per spiccare il volo e abbandonare il suo odiato paesino di provincia, che non offriva eccitazione né prospettive, per mettere in pratica tutto ciò che Lanegan aveva sempre sognato, viaggiando per il mondo a suonare, cantare, conoscere i suoi idoli musicali e battere le strade dei vizi e della perdizione: occasione di una svolta che poi si presentò tramite l’incontro coi fratelli Conner e la nascita dell’epopea degli Screaming Trees.
MARK LANEGAN
Pane al pane e vino al vino, Lanegan non era ruffiano nei giudizi, non usava mezzi termini e ha ricordato e riportato avvenimenti, impressioni, commenti e riflessioni, sciorinandoli con onestà intellettuale, non ha cercato alibi per le sue fragilità caratteriali e personali, ammettendo di avere sempre avuto un problema serio di dipendenza dall’alcool e poi il suo rapporto travagliato con le droghe pesanti, che lo aveva quasi ucciso, autocondannandosi per non essere riuscito a tenere a freno le sue debolezze e sconfiggere i suoi demoni per troppo tempo.
Non si è autoassolto per il male causato ad altre persone, né al tempo stesso ha mostrato pietà o pentimento per i comportamenti violenti e i rapporti bruscamente troncati con chi gli aveva mancato di rispetto, lo aveva vessato psicologicamente e/o aveva provato a “fotterlo” o sbeffeggiarlo: basti pensare, in primis, all’odio che nutriva nei confronti della madre (anche lei venuta recentemente a mancare) rea di avergli tarpato le ali, di non avere mai mostrato affetto né amore, e aver deriso ogni interesse e passione del giovane Mark; o ancora, ai “boss” della Sub Pop Records che avevano ingannato e tradito la sua fiducia; ai rapporti burrascosi con gli ex compagni di band nei Trees, soprattutto con Gary Lee Conner (chitarrista e architetto del suono “grungedelico” ) in anni in cui si era sempre sentito oppresso dalla leadership totalizzante del corpulento songwriter, che non gli faceva esprimere pienamente la sua arte (i due, come sappiamo, si sarebbero poi riconciliati solo pochi mesi prima della morte di Lanegan).
C’è il resoconto disperato degli anni in balìa della tossicodipendenza, segnati dagli sbattimenti, dal costante pericolo dei “withdrawals” sempre in agguato, dalla necessità di “farsi” come unico scopo nichilista dell’esistenza, e di procurarsi “la medicina” a qualunque costo e con ogni mezzo (con relative dis-avventure in giro per il mondo narrate a corredo, inclusa l’attività da pusher) per stare meglio e lenire le proprie sofferenze fisiche e la dannazione spirituale, diventando schiavo dell’eroina e restando fedele solo a essa, e mentendo alle persone fidate, con la conseguenza di mandare all’aria relazioni sentimentali e quasi compromettere la propria avventura musicale (oltre a distruggere la propria stessa vita).
C’è l’amore viscerale per la musica (avendo una delle sue prime epifanie giovanili ascoltando i 45 giri punk presi dal negozio di dischi del paesello, e poi scoprendo i Joy Division – e infatti, non a caso, la prefazione di questo libro è stata affidata a colui che è stato il bassista di quel combo, Peter Hook – che gli ha permesso di uscire dal contesto della provincia bigotta/destrorsa americana e suonare in giro per il globo, avendo rapporti con figure eminenti del punk rock a stelle e strisce (Greg Ginn, Greg Sage) offrendo uno spaccato sulle peripezie vissute durante la registrazione dei vari album, conoscendo eroi musicali come Johnny Cash e Jeffrey Lee Pierce (al quale lo legò una fraterna amicizia) stringendo legami profondi con Dylan Carlson, Josh Homme (per un breve periodo suo compagno di band nei Trees, e poi nei Queens of The Stone Age) Kurt Cobain (che Lanegan ha sempre considerato un genio dal talento smisurato, e che ha rappresentato uno dei più grandi rimpianti della sua vita, non essendosi mai perdonato il fatto di non aver risposto alle sue telefonate la mattina del 5 aprile 1994, giorno in cui il frontman dei Nirvana trovò la morte, e allacciando poi un rapporto controverso con la di lui moglie Courtney Love che, da quanto appreso nel capitolo finale del libro, in seguito ha pagato a Lanegan un anno di ricovero in un rehab in California per trattamento di disintossicazione dalle droghe pesanti) e Layne Staley, in un rapporto di intima fratellanza col frontman degli Alice In Chains con cui ha condiviso tour, palchi, canzoni, dischi (come la partecipazione dei due al supergruppo Mad Season) il sonno, l’appartamento, i fantasmi dell’essere junkies e l’empatia di Mark per le pene d’amore di Staley, la cui prematura morte (che chiude la biografia) avvenuta il 5 aprile 2002, ha lasciato un vuoto incolmabile nell’animo di Lanegan.
Ma non mancano episodi che suscitano anche ilarità e strappano un sorriso, come la vicenda di un tour americano nel 1996 al quale gli Screaming Trees parteciparono insieme agli Oasis, dove vengono riportate le provocazioni fanciullesche da bulletto (circondato da guardie del corpo) di Liam Gallagher, condite da invito a fare a botte nella data finale di Miami, invito al quale Lanegan rispose prontamente, ma a cui poi il giovinastro Gallagher si sottrasse tornando in Inghilterra prima della fine della tournée (a causa, si disse, di litigi con la sua band).
Certo, avrei/avremmo desiderato che si andasse oltre il 2002, ormai smaniosi di leggere anche dell’esperienza coi QOTSA in un disco staordinario come “Songs for the deaf“, delle sue valutazioni sulle svariate collaborazioni musicali e progetti paralleli, ma l’autore aveva scelto di lasciare al lettore libera immaginazione sul seguito della bio (e gli ultimi anni di vita del cantante, alle prese con l’esperienza drammatica del covid-19 e successiva convulsa convalescenza in Irlanda, sono stati descritti in un più recente libro autobiografico, uscito nel 2021, “Devil in a coma“, e il suo talento nella scrivere versi lo aveva dimostrato rilasciando, nello stesso anno, una raccolta di poemi, “Leaving California“).
A questa autobiografia va riconosciuto il merito di essere ruvidamente sincera, non concepita per essere una auto-fellatio celebrativa e buonista, ma per sbatterci in faccia la personale visione e versione dei fatti fornita dal protagonista principale senza peli sulla lingua (anche a costo di farsi odiare) rustica, scorbutica e tagliente. Rock in peace, Mark.