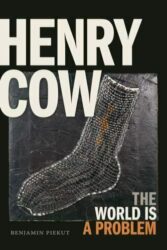Questa recensione è dedicata alla memoria di Gianni Lenoci, pianista improvvisatore e compositore, furioso gentiluomo di provincia, scomparso il 30 settembre del 2019
È un’ipotesi tutt’altro che campata per aria che le grandi metropoli europee (e di tutto il pianeta) abbiano dismesso da tempo il ruolo di incubatore delle avanguardie e siano diventate, sul piano delle energie artistiche e creative, degli enormi riproduttori di cliché ormai quasi interamente dominati e manovrati dal mercato e dall’industria culturale per i suoi propri tristi fini.
Ne deriva che forse è nelle province che possiamo trovare alcune fra le espressioni più avanzate e dense di energia nuova, in campo musicale senz’altro ma certamente anche in altre forme di arte, vivente (teatro, danza, performance) e non (letteratura, cinema, arti figurative).
Gli esempi sono innumerevoli ma mi soffermo su un paio che mi hanno colpito in modo particolare in questo scorcio di fine estate, dominato dai conflitti (questi sì davvero provinciali in senso deteriore) fra l’individualismo liberista-autoritario e quello pseudo-libertario, entrambi impegnati a sventolare le loro bandiere, entrambi alieni a qualsiasi forma di pensiero che implichi una liberazione collettiva o una relazione fra esseri umani consapevoli della propria fragilità.
Il tratto che unisce il lavoro di Elvin Brandhi e quello della band francese Legraux Tobrogoï pare anche essere, insieme alla comune origine periferica, la parola “acharné” che quest’ultimi, originari di Toulouse (non proprio un villaggio sperduto ma pur sempre provincia in un paese Parigi-centrico) usano per definire la loro musica strumentale e per rinforzare gli altri due termini con i quali la definiscono: jazz e populaire.
È interessante, a questo proposito, osservare alcune delle traduzioni in lingua inglese trovate sul web per questa parola, tutte chiaramente di origine latina: fierce, determined, furious, intense, obstinate, strenuous, irreconcilable.
Ne viene fuori un soggetto decisamente antico, novecentesco, un soggetto che lotta in sintesi, anche se nel nostro caso lo fa sul piano del linguaggio musicale e poetico, un soggetto decisamente poco presente nella post-modernità consumista e disillusa, così diffusa nelle metropoli contemporanee che puntano invece decisamente all’acquiescenza, culturale e ovviamente politica.
Ed è interessante altrettanto notare come tutte quelle parole calzino a pennello pensando all’effetto prodotto sull’ascoltatore dalle performance improvvisate di Freya Edmondes, in arte Elvin Brandhi, una giovane performer cresciuta fra il Galles e il North Yorkshire, e che si è fatta notare per la prima volta nel gruppo Yeah You, creato col padre e le cui performance sono state registrate in automobile, durante alcuni loro viaggi, un po’ sullo stile del duo americano Clown Core, ma in uno spazio più ristretto, senza autista e tutto rigorosamente registrato senza editing.
Elvin non è rimasta nella sua provincia però e appena ha potuto ha intrapreso una vita nomade che, a differenza di altri suoi coetanei fighetti tutti costretti nel consueto giro NY-Parigi-Londra-Berlino, l’ha portata a varie collaborazioni e residenze in Africa e Medio Oriente, senza trascurare qualche passaggio sulla scena sperimentale londinese in cui ha improvvisato pure con veterani del calibro di Pat Thomas e addirittura Tony Allen e un periodo di studi d’arte a Vienna che tutto sommato è una città che ha perso da tempo la centralità culturale che aveva due secoli fa.
Cosa fa in sintesi Elvin? Le sue produzioni discografiche più recenti, tutte rintracciabili su bandcamp, sono decisamente orientate a una sperimentazione elettronica che potremmo definire una “Ableton music” piuttosto schizzata e che, al pari di molte altre esperienze simili, sembra molto vincolata dall’uso della macchina e del relativo software, sebbene caratterizzata dai numerosi field recordings raccolti durante i suoi viaggi.
Quello che invece risulta più interessante è l’aspetto vocale e improvvisativo, all’insegna di quel furore di cui sopra e che troviamo realizzato in modo impressionante nella sua performance realizzata allo storico festival tedesco di Moers, durante l’estate scorsa e in compagnia del contrabbassista di origine svedese Joel Grip, impegnato apparentemente sullo strumento antico, con corde di budello e archetto barocco.
Se siete interessati a un primo incontro con l’aspetto performativo della vocalista gallese io consiglio senz’altro questo, qui Elvin è impegnata in un entusiasmante corpo a corpo con la macchina, gli effetti con i quali modifica la sua voce in tempo reale e i field recording che appaiono imprevisti all’interno del flusso sonoro.
Pare quasi una “spoken poetry” improvvisata la sua ma è praticamente incomprensibile quello che dice, un farfugliamento e un urlo forse, malgrado dei fogli sul tavolo suggeriscano che stia leggendo qualcosa.
Il risultato è sperimentazione vocale pura, filtrata dalle macchine e in cui non c’è nemmeno uno dei tanti momenti morti che caratterizzano la musica di molti altri che, impegnati per lunghi momenti a manovrare i loro utensili digitali, lasciano nel frattempo che non succeda niente di nuovo a livello sonoro.
Questo con Elvin Brandhi non accade, la sua performance non ha un secondo di pausa e si lascia ascoltare con grande interesse dall’inizio alla fine.
È lei stessa peraltro a confermare la sua attrazione per questo aspetto quando in una recente intervista afferma che: “…mi sento molto legata al contesto. È per questo che l’improvvisazione funziona, perché sento che l’immediato è sempre stato lo spazio in cui esisto…”.
Quale sarà l’evoluzione di un’artista di questo genere è difficile immaginarlo, potrebbe passare ad altro o approfondire gli incontri, la sua giovane età e la sua attitudine “situazionista” lasciano aperta ogni ipotesi, nel frattempo è un piacere ascoltare queste sue prove così “strenue e determinate” che sembrano anche ereditare e rigenerare le intenzioni di altri vocalisti sperimentali inglesi delle generazioni precedenti, come Maggie Nicols e Phil Minton.
E chi sono invece i Legraux Tobrogoï? Sarò sincero: è un gruppo che esiste da più di 20 anni ma che non avevo mai sentito. Il fatto è che, nonostante la confinanza fra Italia e Francia, le informazioni circa le due rispettive scene musicali sono sempre piuttosto scarse, come del resto mi confermava un recensore d’oltralpe tempo fa.
Tocca quindi, come è capitato a me, di seguire la segnalazione di qualcuno su Mastodon mantenendo comunque sempre viva la curiosità e l’attenzione al nuovo.
Lo stupore è stato notevole ma ormai occorre abituarsi alla contemporanea presenza di tante scene diverse e all’attività di tantissimi musicisti sconosciuti in tutto il globo, alcuni anche davvero interessanti, al di là della loro scarsa fama o forse proprio per questo. O per il fatto di vivere e lavorare appunto in province e luoghi appartati, scarsamente presi in considerazione o annusati dai media mainstream.
Il gruppo, non proprio di giovanissimi, ha una formazione di impianto jazz, anche se abbastanza anomala: accanto alla classica ritmica contrabbasso-batteria compare come strumento armonico la chitarra (il chitarrista Nicolas Poirier è anche l’autore della maggior parte dei brani) mentre la sezione fiati è più classica, vedendo i soliti tromba e sax tenore rinforzati nelle frequenze più basse da un sax baritono, piuttosto “abrasivo”, che sostituisce il più classico trombone, caratterizzando in modo molto marcato il sound del gruppo.
Partendo dall’idea iniziale di quello che loro stessi hanno definito “tziganafreecansound”, la sensazione è che il gruppo, almeno in questo ultimo lavoro intitolato “Pantagruel Résolu” e uscito quest’anno, si avvii decisamente sulla strada di un’intenzione compositiva più complessa, sempre poggiata saldamente sul groove “populaire” ma decisamente più audace dal punto di vista delle strutture e degli arrangiamenti che, tra l’altro e vivaddio, lasciano uno spazio ridotto agli assoli dei singoli, abitudine questa che molte altre formazioni del genere farebbero bene a prendere in considerazione.
La formula del gruppo dunque corrisponde ampiamente alla loro stessa auto-definizione: si trova in loro una sonorità e un’attitudine improvvisativa che rimandano al jazz, l’attenzione alle ritmiche immediate che favoriscono la danza derivate direttamente dalle musiche di tradizione orale di ogni parte del mondo e quel tocco di ostinato furore che non scivola mai nell’aggressività ma anzi stimola l’ascolto e all’energia di chi in qualche modo è inconciliabile con la deriva cool e fighetta di tanta musica d’oggi, creata nelle grandi metropoli dominanti sul piano culturale ma dominate dalle leggi ferree del mercato.