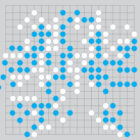A due anni di distanza da “Long walk of the Navajo“, tornano a pubblicare nuovo materiale i californiani Yawning Man, seminale band stoner/psych, alfieri della scena di Palm Desert e padrini del “desert rock”, nonché uno dei segreti meglio custoditi in ambito di “musica alternativa(e)” statunitense.
Quest’anno il trio – oggi formato da Gary Arce alla chitarra, Mario Lalli al basso e Bill Stinson alla batteria – ha dato alla luce il suo settimo album complessivo, “Pavement ends“, uscito il mese scorso sulla label italiana Heavy Psych Sounds. Il disco, a grandi linee, prosegue nel solco tracciato dalle opere precedenti del combo statunitense, continuando a viaggiare su sonorità space rock/stoner/psichedeliche cinematiche interamente strumentali e connotate dal loro proverbiale gusto per le jam creative e “paesaggistiche”, a questo giro rinforzate da elementi post-rock e shoegaze che vanno a rendere più severa e aggressiva la proposta dei nostri.
La copertina dell’Lp (realizzata dall’artista Dianne Bennett) racchiude sei brani tra i più cupi e pesanti mai registrati dall’Uomo Sbadigliante, dalla muscolare e portentosa opener “Burrito power” che squarcia l’aria con un suono nitido di chitarra dai toni apocalittici somiglianti a un grido disperato nel vento, allo space rock di “Gestapo pop“, dal mood malinconico e apparentemente languido, fin quando Arce non si lancia in un catartico assolo chitarristico che fluttua durante una tempesta di sabbia nei deserti della California; “Bomba negra” punta tutto su sonorità più dilatate e atmosferiche, con una solida sezione ritmica Lalli-Stinson che lascia la chitarra di Arce libera di vagare lungo rarefatti flussi spirituali sognanti. “Dust suppression” è un’altra composizione fluida che disciplina un viaggio tortuoso lungo le torride lande dalle parti della Coachella Valley; la title track è un trip space psichedelico di peyote che non conduce all’illuminazione, ma alla frenesia della follia del mal de vivre che caratterizza questi anni bui che stiamo vivendo a livello mondiale, e mai titolo come “Bad time to be alive” (traccia conclusiva dal feeling introspettivo e oscuro, contrassegnata da un’altra melodia “piangente” alla chitarra) fu più appropriato per descrivere i tempi grotteschi e pregni di caos, guerre, avidità e morte che stanno conducendo il genere umano – governato da mentecatti squilibrati – all’autodistruzione.
I pionieri del rock del deserto vanno avanti nella loro viscerale ricerca sonora (in un percorso che dura ormai da quattro decadi) senza confini né limiti ai loro orizzonti emotivi, in cui le parole diventano superflue e allora si dissolvono, lasciando spazio a visioni, contemplazioni, immagini, identità e natura, disegnando scenari che raccontano di una America ancestrale, quella polverosa e silenziosa, ma ricca di storia e tradizioni, lontana dalle narrazioni “vincenti” dei grandi network e colossi ipertecnologici del potere economico/finanziario neoliberista, quella permeata dall’influenza millenaria del mondo latino (oggi criminalizzato dalla politica ufficiale, tra muri innalzati contro le “immigrazioni illegali” e un’esasperante accento posto sui forzati “confini” fisici, e mentalmente limitati, da chi detiene il Potere) che ci invita a ripensare la Natura e al recupero del suo ruolo come protagonista principale e custode della vita su questo pianeta.