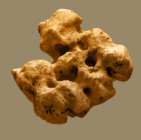Dal buio di una stanza alla fioca luce di un bar nei dintorni di Rauma. Questo perpetuo triangolo si conclude con una felice e attesa recensione che consacra il poeta Alessandro Pedretta con una corona di ferro, ruggine e calcestruzzo. Pesante da indossare, ma necessaria ad alleggerire l’ansia che urla nella stazione di Milano Centrale, tra treni e scale mobili che invogliano soltanto a scappare.
Rubens Lanzillotti cura un’accurata prefazione che induce senza claustrofobia alcuna a seguire un percorso che non collassa sullo stesso convoglio ferroviario, e si può dire che, per quanto la bolgia, le spinte, l’isteria e la frenesia si aprano proprio in un cancello pandemonico, non può che formicolare tra le varie strade che percorrono il suolo del capoluogo lombardo.
Il quadro pittorico fa pensare inizialmente a Bosch o ad un visionario fiammingo che fa della stazione un’enorme bocca che rutta, erutta, sospira, vomita, sputa e bestemmia un andirivieni organico di impiegati, studenti, senzatetto e barboni. Con Puttane a seguito. La cartina tornasole testa una basica acidità di tutto quanto può approdare a Milano (quasi come la via Prè, cugina genovese) senza alcun giudizio. Questo cibo diventa bolo e aiuta a leggere 40 poesie con un unico senso comune: la presenza imposta.
L’imposizione violenta del cemento e di tutta la sua struttura che coinvolge gru, blindo sbarre e impalcature tra le quali si nascondono altre strutture sicuramente meccaniche, certamente post umane. Bosch lascia spazio ad una scenografia di Sironi, pittore che decisamente ricalca il grigio cappotto di un cielo che nulla riveste.
E allora in che modo tutta questa metropolis decadente ed espressionista (ma non qualitativamente tedesca) sa raddolcire il lettore? Come si può trovare dell’oro nero emotivo e non gratuitamente simbolico senza paura di rimanere delusi?
Pedretta scrive con umana delicatezza:
“C’è della poesia che trasuda
in ogni attimo dalla terra
e della poesia che sanguina a fiotti
da queste mani
che fanno lavori inutili la sera
e ti accarezzano disegnandoti le labbra”.
Un sacrificio necessario, la cui malinconia, la cui rinuncia, eleva e ammorbidisce la Musa comune ad ogni poesia. Non è scontato e non è facile amare e odiare contemporaneamente ciò che porta avanti un macchinoso sadismo eppure Milano brilla di questo fascino e diventa migliore solo se si decanta.
L’hinterland, con le sue stasi, ha un’eco di Augé, nell’oblio di un rumore bianco/grigio che pervade i diversi livelli sotterranei di Milano centro.
“Le mie cellule sono come venti
che mi portano a te,
dimmi, veramente, anche tu,
non li senti?”
Siamo quindi pronti ad affrontare realmente questa cacofonia di suoni, casuali quando tutto continua ad avere una continuità infinita? Probabilmente non avremo tempo né coraggio di essere degli Higlander nel disegno divino che Qualcuno ha contemplato per Milano ma, di certo, questo zibaldone di pensieri ci consente di camminare con le nostre scomode scarpe senza dimenticare il suolo che percorriamo, una volta letti e digeriti. Alcune foto aiuterebbero a incorniciare le letture, per essere certi di non aver sbagliato luogo, ma quale altra città se non Milano rende piacevole lo snob come l’Anarchia delle sue stesse mura, al contempo? Facile prendersela con i luoghi comuni che non siano le vie battute o le gallerie antistanti al Duomo, ma la vera città brilla di luce bianca o grigia, e soprattutto rarefatta tra gli stridenti movimenti ferroviari.
Una possibile soundtrack? Penderecki di certo, che di diavoli ne troverebbe a iosa, a Milano, anche più che a Torino.
Complimenti Alessandro