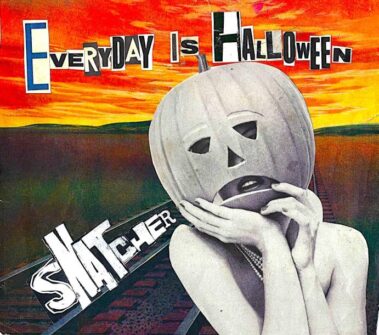Mi è piaciuto anche Dj Coco, a questo giro. A questo quindicesimo compleanno, festeggiato tra i fuochi d’artificio nel suo scenario più suggestivo, il palco Ray-Ban con gli spettatori in Ray-Ban. Alla luce dell’alba, quando ci si volta a sinistra e si riesce a trovare qualcosa di poetico perfino nell’enorme struttura obliqua di pannelli solari, mentre ci si augura con tutto il cuore di ripassarci sotto un anno dopo.
Perché si capisce che son finite le corse, non è più il momento di guardare gli orari e le sovrapposizioni bastarde, di mandare messaggi sghembi per ritrovare gli amici tra la folla, di fare le file al bar o tra le pozzanghere dei bagni. E forse in molti a quest’ora lo pensano veramente, che in fondo questa rimane una delle poche inossidabili certezze attorno alla quale, senza presunzione o snobismo, ci si costruisce il resto dell’anno.
Come al solito pare ci sia meno gente dell’edizione precedente, e regolarmente si è smentiti dalle cifre ufficiali della prima settimana di giugno. Semplicemente il festival funziona sempre meglio, anche se le disposizioni e i nomi dei palchi sono mischiati come in un gioco delle tre carte pressoché ad ogni stagione.
Il mercoledì, per la prima volta da anni, si riesce a entrare senza troppi scompigli alla Sala Apolo, dove le new entries Viet Cong inaugurano nel migliore dei modi il quindicennale: più solidi e compatti che da disco, sorretti da una sezione ritmica invidiabile, i canadesi riaprono il Festival nello stesso palco e nello stesso modo in cui si era chiuso l’anno prima, col concerto monumentale dei Cloud Nothings. Stessa estasi di sudore, spintoni e cori, in una performance più cupa ma altrettanto tagliente e distorta. Meno incisivo, per le mie corde, il successivo funk-disco degli Juan MacLean che chiude la serata prefestival.
Il bello arriva giovedì, che parte con il pop carino dei Twerps, ovvero la risposta imberbe ai più quotati Real Estate. Di ben altro spessore è lo show dei Battles nel riservatissimo Heineken Hidden Stage, per i quali vengono staccati non più di un centinaio di biglietti. Set perfettamente bilanciato tra quattro brani inediti e le canzoni di apertura di Gloss Drop (esemplari le infuocate Africastle, Ice Cream e Futura). Atlas è invece l’unica concessione all’album d’esordio Mirrored. Ian Williams e soci appaiono come al solito difficilmente paragonabili alle band che siamo abituati ad ascoltare negli ultimi anni: ogni suono, ogni parte ritmica, ogni viaggio strumentale è drammaticamente, perfettamente calibrato, anche se il trio di New York pare ci giochi sopra con assoluta leggerezza, rendendo semplici delle strutture impossibili. Non azzarderanno i posteri a chiamarli i King Crimson del nuovo millennio. Alla fine sarà il concerto migliore della giornata, anche perché arrivo tardi per i Replacements e li ascolto da troppo lontano per formulare un giudizio. Me ne pento amaramente, almeno a rivedere i video e a sentire i pareri di chi invece li ha ammirati con attenzione.
L’enigma del giorno arriva con l’attesissimo set degli Spiritualized. Suoni ottimi per il difficile palco ATP, band ispirata ma scelta azzardata della scaletta, e soprattutto brani in versione eccessivamente shoegaze. Jason Pierce praticamente rientra negli Spacemen 3, ma senza i brani degli Spacemen 3. Ho contato cinque pezzi in un’ora, in cui francamente perso di vista il britpop interstellare della band di Rugby e non sono riuscito a perdermi nelle loro lunghe note.
Chet Faker è bello e bravo, e ha una voce da pelle d’oca. D’alto canto per la prima metà concerto si limita a cantare sulle basi, senza aggiungere sostanzialmente niente. Poi esce la band, ed è veramente uno spettacolo, ma rimane l’amaro in bocca per la prima parte che poteva far splendere il concerto in tutt’altra maniera. Invece, a seguire, è perfetto James Blake, l’ electro-writer inglese ormai “giovane con esperienza”, che lascia da parte la post-dubstep e travolge con bassi avvolgenti che sfiorano l’introspezione, in uno dei concerti più emozionali di tutto il festival. James Blake brilla di luce propria, e sembra trasformare il palco più grande e dispersivo in un’arena illuminata di candele, col pubblico in religioso silenzio per tutto il set. Finirei qui, invece provo ad ascoltare Richie Hawtin. Non dovevo farlo, son troppo vecchio e ho il terrore che spunti qualche gabber direttamente dagli anni ’90. Il mio giovedì finisce qui.
I New Pornographers aprono quella che è solitamente la giornata moscia del Primavera Sound, il venerdì. Lo fanno bene e sono molto piacevoli, soprattutto per quanto riguarda i preziosi arrangiamenti di voce. Interessanti mono tappeti di synth su basi post punk arrivano dal piccolo palco Adidas Original, dove i White Hills, una coppia di tossici non domi, agghindati come i Cramps del futuro, giocano bardati di tutine glam con un garage psichedelico che non lascia indifferenti.
Mi aspettano due dei concerti più emozionanti a cui mi sia capitato di assistere in tempi recenti, seppure diametralmente opposti in quanto a stile e attitudine: Perfume Genius, algido ed etereo, nel suo pop rock avanguardistico mette in scena il capolavoro Too Bright tra echi onirici e intermezzi soul gospel di una qualità infinita. Gli Hoteliers invece stupiscono con il loro emocore di indole nostalgica ma non per questo scontata, tra singalong di teenager innamorati e ritornelli tra il pop punk e uno screamo inconsueto.
La reunion dei Ride mi riporta alla mente il concerto degli Slowdive dell’anno precedente: tanto tempo senza gli strumenti, una gran voglia di suonare, una compattezza e una grazia che superano ogni più rosea aspettativa: nessun dubbio nel considerare il concerto di Andy Bell e soci una delle performance migliori dell’intero festival.
Vuotissimi, invece, i Death From Above 1979, i quali album iperprodotti necessiterebbero di ben altri suoni o quantomeno di un paio di turnisti sul palco per valorizzare lo show.
Si fa tardi e si arriva al gran finale della seconda giornata: i lucidi sogni di Jon Hopkins in forma di schegge elettroniche illuminano il palco ATP, la sua elettronica colta tocca i confini del pop arrivando a un pubblico normalmente non educato alle dinamiche del panorama elettronico attuale. Una ennesima conferma di un talento ormai indiscusso della nuova tecnologia sonora.
Il sabato sono lacrimoni: i DIIV entusiasmano tutti tranne me, che non son mai riuscito a considerarli più di un gruppettino sopravvalutato. La cosa migliore che fanno è lasciare spazio agli American Football, per cui ogni parola spesa qui sotto ha poca attendibilità.
Vedere Mike Kinsella e soci è uno di quei miracoli che non ti aspetti, come ritrovare per strada un amico fraterno di cui non sapevi più niente da decenni. Sciolta dopo un solo album, riformata dopo quindici, la band dell’Illinois esegue pedissequamente tutte le canzoni del disco omonimo e probabilmente lo fa meglio di tre lustri addietro. Non aggiungono né tolgono niente ad un set pressoché uguale in tutto il tour, ma quello che conta di più è che ci siano, che abbiano dato la possibilità a tutti i fan di poter finalmente ascoltare i capolavori di un album storico. L’importante era esserci, e onorare coloro che (prima ancora con i Cap ‘n’ Jazz) hanno ispirato decine di band dal math rock all’emocore di ultima generazione.
Ancora stordito, perdo gli Sleaford Mods e mi dirigo verso i due palchi grandi, Primavera e Heineken, per aspettare il live dei Foxygen (pare) dal tour di chiusura della loro carriera. Per l’ennesima volta mi trovo davanti a Mac Demarco, che non ho mai apprezzato e difficilmente apprezzerò. Fa l’amicone, non se la tira, ha un diastema irresistibile, ma le sue canzoni son ordinarie, piatte, insipide. Se poi ci aggiungiamo una cover di Yellow dei Coldplay fatta male e con la scusa banalissima della rottura di una corda di chitarra (gag presentata già una decina di volte nell’ultimo tour), la cosa si fa grottesca.
I Foxygen fanno invece tutto ciò che non mi aspettavo: riarrangiano pressochè la totalità dei loro brani, suonano freschi e compatti, e hanno un feeling sul palco che tutto lascia presagire tranne lo scioglimento della band. Il loro leader, Sam France, è un perfetto connubio tra il Ziggy Stardust più etereo e gli urletti del Jagger fine anni ’70. E in effetti pare la fiera del citazionismo, dai Grateful Dead ai Beatles, in un circo luccicante e paradossale tanto eccessivo quanto inaspettatamente divertente.
Gli Unknown Mortal Orchestra presentano un convincente e sognante set blues rock annegato nella psichedelia, con suoni molto più zozzi rispetto agli album, perché asciugati dei beat più dance (in particolare dell’ultimo lavoro multi-love). Gli Strokes sono quanto di più deprimente si possa immaginare, soprattutto visti da chi li ha amati per anni. Sembra difficile poter suonare male i propri pezzi, quando pochi anni prima li si suonava benissimo. Gli Strokes ci riescono, facendomi imparare una cosa: non importa quanto tu sia famoso, quanto il palco che calchi abbia fonici clamorosi, quanti strumenti perfettamente accordati ti passino i roadie: se non hai più voglia di suonare, farai uno spettacolo vergognoso. Inutile sparare sulla Croce Rossa menzionando stazza, outfit e timbro di voce di Julian Casablancas: quello che mi passa per la mente è l’immagine di un junkie senza denti e coi ciuffi colorati che suona scordato in una metropolitana qualsiasi.
La situazione migliora notevolmente col solito coloratissimo spettacolo di Dan Deacon, a base di balletti sotto il palco e poliritmie minimaliste. Mi aspettavo qualcosa di più dagli Health, in un set meno punk e più drone dell’ultimo visto al Parc del Forum. Mentre lo spettacolo finale, e permettetemi, il miglior concerto dell’intero festival, arriva alle tre del mattino nel palco Ray-Ban. Il signor Daniel Snaith, ovvero Caribou, trasforma i beat più ambientali e spezzati del recente Our Love in un viaggio esoterico nell’elettropop, dilatando le strofe all’infinito (la finale Sun è qualcosa di indimenticabile) e ritornando virtualmente alle atmosfere più deep-house e elettro-funk del precedente Swim. Snaith raggiunge dal vivo la sua piena maturità artistica, e come uno sciamano ci tiene per mano nel migliore dei finali possibili di questo festival, di questo grande compleanno, di un festival per cui si son spese veramente tutte le belle parole possibili.
Si parla già di headliner per il 2016, di grandi reunion e di possibili ritorni. Ma ormai il Primavera Sound cammina da solo, indipendentemente dai grandi nomi e dalle lineup. Era il miglior festival d’Europa, e anche quest’anno lo ha dimostrato.