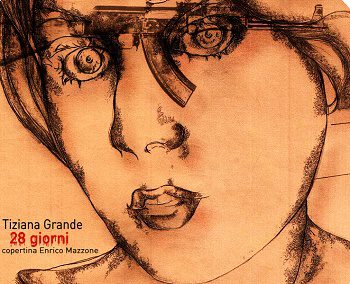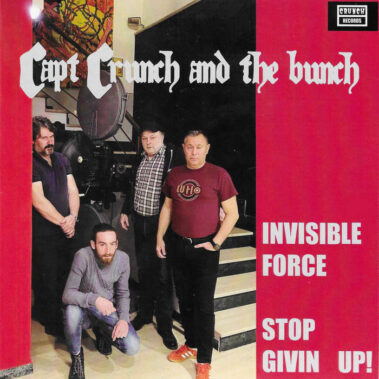28 GIORNI di Tiziana Grande
Giorno 0
“Non capisco… sono cose difficili da capire…”
Il notiziario gracchia.
Spengo la radio. In trappola nel traffico da un’ora, non ci si muove. I clacson urlano inutilmente, qualcuno scende dalla macchina, pestando i piedi e allargando le braccia, impreca, dal suo labiale leggo bestemmie audaci. Io ho spento il motore da un pezzo, ho fatto finta di ascoltare un po’ di musica, in realtà non ho ascoltato nulla, nessuna melodia ha catturato la mia attenzione, tutto mi giunge indifferente ed ovattato: i clacson, le bestemmie, il borbottio del traffico, continuo, incessante, ormai parte del mio cervello.
Guardo fisso il finestrino. Cominciano a scendere alcune gocce di pioggia, ne seguo la traiettoria, procedono lente in assenza di vento, guardo, ma non vedo, il loro quasi impercettibile zigzagare tra lo sporco del vetro. Guardo, senza vedere, perché non c’è nulla di interessante in quelle gocce. Sono fuori casa dalle 6.45 del mattino e l’orologio sul cruscotto ha appena battuto le 19.00, un altro inutile cambiamento di stato in questa snervante immobilità.
Lo stomaco inizia a brontolare, il tramezzino ingurgitato nei minuti di pausa dalle 13 alle 13.15 ha già fatto il suo dovere da un pezzo. Dovrei avere fame, ma non ho neanche la certezza di provare questo bisogno. Debolezza, direi.
Gli occhi bruciano per la stanchezza, la testa è vuota e pesante.
Mi piacerebbe non esistere, l’unico indizio della mia esistenza è questo malessere generale, indefinito, attaccato addosso come una seconda pelle. Cosa c’è di tanto difficile da capire?
Non vi siete mai sentiti così?
Giorno 1
Sono da poco passate le 3.14 e tra circa due ore e mezza devo essere già fuori casa, nel collo di bottiglia del traffico mattutino, col freddo smog che trapassa i polmoni. Non ho chiuso occhio. Fisso il soffitto da non ricordo quando e credo di aver sperimentato forse una decina di minuti di dormiveglia: ho avuto una visione ipnagogica, una persona mi vegliava ai piedi del letto, ma era una nuvola, uno sbuffo di fumo. Questo è stato il mio momento di riposo, per oggi non ne avrò altri e forse neanche domani.
Gli spilli dentro agli occhi mi accompagneranno per tutta questa ignobile giornata di merda. Vi chiederete, ma come fai ad avere la certezza che la tua giornata sarà di merda? Ma è così. Quanti di voi hanno questa sensazione ogni mattina? Vi assicuro che non primeggio in originalità e non profetizzo sventure. Eppure molti di voi mi daranno ragione, come se fossimo intrappolati in una gabbia invisibile dalla quale abbiamo, in teoria, la possibilità di scappare. Ma non lo facciamo. Io oggi non lo farò. E neanche domani.
Fisserò il soffitto fino al momento di dovermi alzare, lascerò i miei pensieri fluttuare cercando in essi qualcosa di bello, di rassicurante che non trovo. Non lo trovo mai. Cerco di immaginare prati immensi, acque cristalline, il calore di una carezza, un buon odore. Nulla. Da troppo tempo le privazioni mi hanno gettato in uno stato semi-larvale. Penso che le sinapsi che riconducono al bello, al buono e al rassicurante si siano recise.
Provo a chiudere gli occhi e a seguire dei lampi bianchi e rossi che sembrano venire sparati dall’interno della testa. Il battito cardiaco accelererà un po’, sembra che queste visioni siano eccitanti, in qualche modo. Come fossi in una giostra, in tenera età.
Il rombare violento di una moto mi fa sobbalzare e quindi decido di alzarmi.
Giorno 2
Sono in un cabinotto di un metro per un due da ormai cinque ore. Chiamo e richiamo sconosciuti cercando di vendergli pacchetti di offerte telefoniche assolutamente non convenienti. Ripeto sempre le stesse cose, da cinque ore, da mesi. Salve, la chiamo da. Partono già gli insulti, a raffica. Altro numero, altri insulti o dinieghi. Vorremmo proporle… no, non mi interessa.
Ho terminato la lista, devo pisciare. Passa il capo e mi chiede quanti clienti ho agganciato: oggi nessuno, dico io. Richiama subito tutti quelli della lista. Richiamo, gli insulti sono peggio dei precedenti e molti chiudono ancor prima che io parli. Passano altre due ore e non ho ancora potuto pisciare.
Siamo nell’era avanzata, negli anni del progresso e del benessere, ma troppo spesso la felicità consiste nel poter svuotare la vescica. Solo questo.
Non per tutti, certo. Per molti, alla base della piramide.
È bella questa cosa, che tutti possono essere felici in qualche modo, indipendentemente dal posto assegnato lungo la piramide. Io ho provato la felicità di pisciare. Ma ho commesso un errore: subito dopo ho indugiato, ho fissato le piastrelle azzurre del piccolo bagno e, no, non dovevo indugiare su quel pensiero.
La felicità nel poter pisciare è degradante?
Ho fatto mente locale, ancora, su qualche scarto di felicità da provare.
Si, una sigaretta. Ecco quello che ci vuole.
Inspirando un po’ di morte dal tabacco ho provato sollievo, effimero anche questo; dai cerchi di fumo ho visto delle sbarre. Sono in una fottuta prigione, una prigione ologramma. Come cazzo si esce da qui?
Giorno 3
Quando il nemico è invisibile, la rabbia è invisibile. Non ho un obiettivo da colpire, il mio pugno vaga per aria senza toccare nulla. Il mio capo stronzo? La collega pettegola? Il vicino antipatico? Il governante corrotto? Il criminaloide molesto? Tutti e nessuno.
Eppure la sento, questa rabbia. Parte dal basso ventre e si irradia fino alla fronte, pulsando forte alle tempie. Prende le spalle e ti fischia nelle orecchie. I canini cominciano a piangere saliva, come antiche lacrime, le mascelle si serrano come a contenere un flusso di forza oscura proveniente da chissà dove. Bisogna respirare. Ampi e lunghi respiri.
Cosa c’è da capire?
Stringo le nocche e chiudo gli occhi.
Mi lascio andare sul divano e accendo la TV. Passo i canali a raffica, non guardo niente, è il semplice movimento del pollice sul telecomando a darmi una calma apparente. Come se davvero stessi facendo qualcosa, come se stessi operando una scelta. Ma io non ho nessuna scelta.
Mi blocco su una stupida televendita di attrezzi ginnici e poi alterno con un documentario sullo sterminio nazista. Non avverto alcuna variazione di stato nella mia mente, la stessa apatica indifferenza. Una deficiente imbellettata che fa addominali in terra mi fa lo stesso effetto di un essere umano ormai scheletro aggrappato a del filo spinato. Il mio cervello non registra cambiamenti di sensazioni, come se avessi un filtro oltre la retina.
La mia rabbia è sempre lì, indifferente, rivolta al nulla, va scemando solo grazie alla stanchezza.
Sento che i miei occhi vogliono chiudersi.
Scelgo di spegnere la TV. Sarà una scelta? Lo schermo vuoto mi rende lo stesso niente delle immagini di poc’anzi.
Giorno 4
Quindici minuti di pausa. Posso uscire dal mio cabinotto puzzolente.
Mi reco al solito bar e prendo un tramezzino, anzi due. Da qualche tempo li hanno rimpiccioliti lasciando invariato il prezzo, tanto chi lavora in zona non ha scelta. Un altro bar è più lontano, cinque minuti di strada che non puoi permetterti. Il trade-off tra tempo e denaro, la falsa scelta che opprime la maggior parte di noi, qua, ai piedi della piramide. Rinuncio alla bibita, berrò in bagno, l’acqua dal lavabo. Queste misere decisioni mi fanno rabbrividire.
Il pasto non è buono, lo devo ingurgitare per evitare svenimenti. Penso al “buono”, ma non ricordo nulla di recente con questo attributo. Forse dovrei pensare al “bello”, ho sei minuti da far passare. Il tempo è nuvolo, umido, non freddissimo. Mi guardo attorno. Una zona industriale nel mezzo del quasi nulla, capannoni, un ingrosso di mobili deserto, un ex-magazzino sventrato e abbandonato. Qualche macchina parcheggiata davanti alla sede di questa tetra compagnia telefonica in crisi.
Allungo la visuale, forse il “bello” si vuole nascondere oltre. Scorgo dei fumi di fabbriche lontane, oltre uno spazio desertificato. Dunque lo abbasso lo sguardo, verso i miei piedi. Ci sono un mozzicone di sigaretta e una cimice che arranca lenta tra i dislivelli del cemento. Allora forse è caso di chiudere gli occhi per l’ultimo minuto, pensando a qualcosa di “buono” o di “bello”.
Un minuto è troppo poco. E poi c’è una puzza immane di gas unita ad un rumore continuo di trapani e martelli che lavorano incessantemente chissà dove. Inutile, non ci riesco.
Neanche l’immaginazione può più salvarmi, sono alla deprivazione quasi assoluta dei miei sensi, ormai aggrediti solo da brutture.
Non saprei, non vi capita mai?
Giorno 5
Ho parlato di oppressione, ai piedi della piramide. È evidente. Con questo non voglio dire che quaggiù ci siano solo tristezza ed infelicità. No anzi. Vedo i miei simili, a questo stadio, inebetiti ed inconsapevoli ma non del tutto disperati. Non allungano neanche una mano per toccare le pareti della loro prigione. Così almeno credo, poiché difficilmente mi approccio a loro. Mi giunge ogni tanto l’eco dei loro pensieri, un’onda indefinita che pare accomunarmi a questo magma umano estraneo ma vicino. So bene che la mia è una visione ristretta e parziale, la visione di chi vive in questa particolare schiavitù, materiale e mentale, questa massa composita di non-individui. Non riesco ad immaginarmi qualcosa come la “libertà”. È un grosso limite. Come non riesco ad immaginarmi una felicità pura, non dettata dall’assenza di miseria. E non so se questi miei simili riescano ad immaginarsela.
Sono in fila da mezz’ora in un devastante centro commerciale, per necessità di cose, purtroppo. Cerco di far passare questo tempo perduto osservando gli altri, indaffarati, stanchi, annoiati, sorridono con la loro schizofrenia palese. Spingono carrozzine con pargoli urlanti e comprano cose inutili, navigano in un limbo di non-esistenza, ma non voglio dar aria alla mia presunzione. Dai margini li vedo lontani da me, ma neppure io esisto, quasi come loro. Stranamente mi giunge il brontolio del loro vuoto che riconosco come familiare. Chiunque potrebbe assomigliarmi in fondo, quel baratro che vi sembra scavato tra me e loro, tra me e voi, non è così profondo.
Credete che io stia sperimentando un qualche tipo di diversità estrema?
Ma non saprei…
Vedo la mia solitudine riflessa in tutti gli altri come una stanza di specchi deformanti, occhi cloroformizzati che si incrociano senza vedersi, sguardi assenti che scrutano l’assenza.
Io lo so che mi capite.
Giorno 6
Sono in stato di veglia da 75 ore ormai. Ho scorpioni che danzano intorno al plesso solare. Ho persino iniziato a pregare, Morfeo. Non so dove l’ho sentito nominare, non ricordo.
Ho prurito a tutto il corpo, come formiche assassine invisibili appena sotto la pelle. Calore e brividi di freddo si alternano in modo casuale senza connessione alcuna alla temperatura ambientale. Vivo in un pianeta sconosciuto, il mio involucro di carne dal metabolismo completamente sballato. La centralina, il cervello, deve aver innescato un qualche processo occulto che inquina tutte le normali funzioni.
Ma non ho alcuna malattia. Possiedo buona salute, a quanto pare.
Sono da poco passate le cinque del mattino, apro la finestra e una nebbia fumosa mi assale, s’infiltra nei mie polmoni, fredda e acida; avverto le polveri sottili che pizzicano l’interno del mio naso e scendono velenose nella gola. Questo pianeta non durerà a lungo, poco m’importa.
Fuori, per le strade ghiacciate si aggirano i primi disgraziati della giornata, li scorgo imbottiti nelle loro giacche pesanti, quasi indistinguibili per sesso ed età. Decido di unirmi a loro, senza un motivo preciso. Una forma di umanità in quella disumanità mattutina. Se guardo ancora il letto rischio davvero un crollo di nervi. Ho quasi due ore di buca prima dell’inizio del mio calvario lavorativo.
Mi imbacucco e mi metto ad aspettare il primo autobus, così, in mezzo a quegli zombie cascanti di sonno, infreddoliti fino al midollo. Salgo su un mezzo a caso, una specie di quasi-notturno che raccatta i primi schiavi del mattino e li avvicina alle loro prigioni. Siamo in pochi e avverto già la puzza terribile degli aliti sfasciati dallo stress e dalla mancanza di cure. Tipici odori delle periferie urbane, così dappertutto.
La nebbia fuori rende tutto più surreale, c’è quasi della poesia in quel paesaggio alienante, ripetitivo, tetro, classico di questi enormi agglomerati-ghetto, polveriere a cielo aperto.
Faccio un’andata e ritorno dal capolinea e alle 6.30 è ancora buio.
Giorno 7
Il tramonto scende e come al solito mi assale quel terrore senza nome che accompagna abitualmente le mie interminabili notti. Come un sipario nero che cala sopra i miei occhi, li costringe a rovesciarsi e a guardare dentro al cranio: figure danzanti orride, ombre che cambiano forme sempre grottesche, ectoplasmi dei miei pensieri.
Cerco di distrarmi e mi connetto al web. Provo a sorridere di qualche meme sul social network, provo a svagarmi col nonsense delle conversazioni virtuali. Un fake mi scrive “Ciao”, non replico, non vorrei ricadere nelle trappole che la mia stessa mente appronta. Una volta ho intessuto una comunicazione affettivo-sessuale con non-so-chi, consapevole dell’assoluta artificialità dell’esperimento. Credo che molti di voi possano capirmi. La mia pelle non ha contatti con altre epidermidi da tempo immemore. Da sempre forse. Non ricordo più, o forse non posso ricordare, il tocco di una carezza altrui, né i miei polpastrelli su centimetri di corpo che non sia il mio. Sul perché ci si riduca in questo stato ci sarebbe molto da dire, pare sia una scelta individuale ma io non credo in nessuno spazio di scelta, per molti di noi, marionette dai fili invisibili. Ho cercato di capire cosa potesse significare il contatto fisico con un mio simile chattando con non-so-chi: a parole, avrei potuto immaginare?
In realtà, quella creatura pensante al di là dello schermo avrebbe potuto essere un robot, poco sarebbe cambiato: io avevo deciso di comunicare con un anfratto della mia mente. Eppure quelle parole dentro al quadratino mi si sono conficcate come spilli nel petto in certi momenti, davvero da impazzirne. Quando l’entità mi descriveva le parti del suo corpo ho avvertito un insistente formicolio ai palmi delle mani, un effetto arto-fantasma indotto. Certe volte bastava che scorgessi il suo falso nome connesso per avere indefiniti scuotimenti al basso ventre e poi giù, fino alle caviglie, un tremore caldo. La sua esistenza era superflua, ne ero consapevole, nonostante ciò attendevo le sue parole, perlopiù banali, ciao, buongiorno, buonanotte come stai? Residui di bisogni lontani, ormai perduti, scarti di attenzioni chissà quando ricevute.
Quanti di voi si sono sentiti così?
Giorno 8
Credo che ci siano lezioni che si imparano molto presto. Ho visto alcuni uccelli assalire un loro simile ferito: arrancava con un’ala sanguinolenta rasente il muro del marciapiede, sbandava, si accasciava ogni pochi centimetri. Avrei voluto ucciderlo, è penoso osservare la sofferenza in natura. Non ho fatto in tempo. Cinque o sei della sua stessa razza gli sono piombati addosso e lo hanno ucciso: gli hanno beccato il cranio, lo hanno aperto come un uovo e hanno strappato quel che c’era dentro. Non so se abbiano mangiato o meno quelle frattaglie, non ci ho fatto caso. Ho notato gli ultimi sussulti del volatile lasciato a terra, scatti di nervi risolutivi, la vita che saluta la signora morte.
Ho avuto il ricordo di come ci si sente in balia dei propri simili, in certe situazioni. Ti si secca la bocca, l’adrenalina ti fotte il respiro, ti si spalancano gli occhi e tutto rimbomba dentro le orecchie. Chissà quanti di voi sono stati accerchiati, da piccoli o da grandi, da branchi ostili. Capita spesso, è nell’ordine naturale delle cose. Bisogna imparare, e in fretta pure. Dentro al branco inospitale ci si ricade spesso. È solo questione di tempo e di grado. Se impari puoi anche passare dall’altra parte, l’identificazione con il carnefice funziona bene, è come invertire una polarità, è semplice. Ho avuto una mia banda verso i dodici anni, avevamo catturato un esponente della tribù rivale, classiche dinamiche dei bambini che hanno la fortuna di poter stare in strada. La vittima avrà avuto dieci anni o meno, immobilizzato per terra. Ho provato esaltazione pura nella punta della mia scarpa che colpiva la sua faccia. Come se l’accessorio fosse divenuto parte di me. Una mia appendice. Un diretto collegamento col mio cervello in fiamme. La gioia profonda della vendetta, pare sia ineguagliabile, ma è meglio non dirlo.
Avrei continuato all’infinito a tirare calci ma la banda aveva deciso che poteva bastare, era il momento di dileguarsi.
Giorno 9
Stavo fissando il vuoto da ore. Ripetevo le manfrine per abbordare i clienti al telefono come un disco. Penso davvero che abbiano potuto scambiarmi per un disco. Ma non lo sono forse già? Il mio livello di assuefazione agli insulti è tale che potrei davvero assurgere al ruolo di macchina-che-parla.
Stavo fissando il vuoto da ore. Devo aver sbattuto le palpebre per pochi istanti poiché mi bruciano ancora gli occhi. Un collega anonimo mi aveva dato un buffetto. Heilà, ci sei? Sei tra noi? Telefono casa? Tutti a sghignazzare. L’ho guardato per un attimo e ho continuato a fissare il vuoto. Ma ho provato per la prima volta in vita mia una strana energia. Un ribollire di fluidi caldi, dalla fronte ai piedi, un formicolio alle mani, un crescere di statura, un gonfiarsi di tutti i muscoli. Una metamorfosi immaginaria molto complessa.
Ho percepito una lotta di potenze: la debole gravità che tiene la tastiera sul tavolo e la spinta opposta delle mie mani che vogliono fracassarla in faccia ad un individuo. Una terza forza oscura ha impedito che spaccassi quella tastiera in testa al collega. Non saprei come chiamarla. Forse uno strano retrogusto che ti sussurra: non ne vale la pena. Quale pena? Ho morso l’interno della mia lingua, ho succhiato un po’ di sangue, il suo sapore metallico mi ha fatto calmare. Quale pena? Avrei provato una gioia indescrivibile nel vedere la faccia di quel babbeo ridotta a brandelli e l’odore del suo sangue mi avrebbe sollevato da ogni sofferenza. Si, forse l’idea di renderlo oggetto della mia gioia mi disgusta un tantino. Sarà stata sicuramente questa considerazione inconscia a frenarmi. Non trovo altri motivi. L’empatia? La sofferenza altrui? Non so che dirvi, sto assaporando il mio sangue, sto soffrendo comunque.
Se n’è andato. Posso tornare a fissare il vuoto. Ho la voce impastata ma tiro avanti con i ritornelli: salve, vorremmo proporle, si ma lei risparmierebbe in bolletta, le espongo il pacchetto di offerte…
Sul piccolo ricevitore del telefono, un grumo rossastro.
Giorno 10
Il mio treno è in ritardo. Mi accovaccio in un angolo di panchina e altro non posso fare che guardare passivamente il paesaggio e gli individui che lo affollano. Sembrano mozziconi di candele spente. Trascinano le loro cose come le loro vite. Tutti guardano il loro aggeggio, se non lo hanno all’orecchio. Non ricordo più quante volte ho vissuto questo non-spaziotempo frattale. E voi? Quante volte? Lo stesso frammento ripetuto all’infinito: che sia una stazione o un aeroporto, un auto-grill o un centro commerciale. Sto appuntando delle banalità, ma io sono banale, una scheggia di questo cemento grigio uguale a tante altre schegge. Nell’intontimento di questa marea di volti estranei che mi passano davanti, giunge quel solito déjà-vu, quell’istante di amnesia che mi buca la mente, che mi inchioda in un’altra dimensione, una delle tante. E chissà in quale anfratto di universi accartocciati vado a precipitare. Non mi chiedo neanche chi sono io?, non ho linguaggio nel pensiero, tutto si resetta.
La vibrazione del cellulare in tasca mi desta, o perlomeno desta quella parte di me ancora vigile. Leggo il messaggio di M., lo registro passivamente e rispondo, come un bot, le solite frasi: il treno-è-in-ritardo-ti-chiamo-quando-arrivo.
Mi pizzico le guance. Memorizzo il numero del treno poiché in questo quadro che ripete se stesso non è facile distinguere gli stimoli visivi e uditivi. La voce monocorde degli annunci delle partenze e degli arrivi sembra una filastrocca di quelle che girano in tondo senza avere mai fine. Devo prestare attenzione ad una sequenza di numeri, soltanto loro riescono a marcare il sentiero in questo groviglio uniforme. Stessi odori, stessi scorci di negozi e fast food, e piccoli automi ripetibili dunque inutili, proprio come me.
Proprio come te.
Giorno 11
M. mi ha detto di aspettare in una piccola chiesetta di periferia. Al solito, sono in anticipo. Ho preso un giorno di finta malattia, si fottessero, tanto la compagnia sta per chiudere baracca: voci di corridoio ci allertano che tra non molto saremo tutti a spasso. I capi cambiano aria, c’è gente tanto disperata che lavorerebbe il doppio per metà salario. Lo sappiamo.
La chiesetta è deserta. Ho visto di scorcio il parroco passare vicino al confessionale con una scopa. Il tipico odore acre dell’incenso e dei ceri, unito all’umidità, mi fa rivoltare lo stomaco. Mi siedo in fondo, vicino all’entrata, fingo di essere in preghiera o in meditazione, tengo le mani incrociate ma cadenti sulle ginocchia e la testa reclinata verso il basso. Non capisco perché M. abbia tutta questa discrezione. Deve propormi un progetto. Me lo aspettavo, chattiamo da tempo ormai, sapevo che prima o poi ci saremo incontrati. Guardo le statue dei santi: una madonna in gesso annerita, un angelo come mille altri angeli e il crocifisso sull’altare, sobrio, scarno, in legno. Non c’è nulla che catturi la mia attenzione, non avverto nessun senso religioso, nessuna emozione, niente. Osservo stancamente questi ninnoli tristi solo perché non voglio abbassare le palpebre, M. mi ha detto di non dare nell’occhio ma di stare comunque all’erta.
Entra una donna, credo la prima del mattino visto che sono da poco passate le nove. La vedo accendere una candela sotto ai piedi della statua della madonna, mi fisso sulla fiammella, i suoi movimenti caotici mi danno un motivo per sopportare l’attesa. La donna si inginocchia nelle prime file e inizia a pregare. Odo la sua flebile litania per qualche istante, poi il silenzio.
L’odore acre comunque sta diventando insopportabile. Conto di uscire a fumare una sigaretta anche se so non essere una buona idea: devo diventare una specie di fantasma. Il che non è difficile nel mondo in cui viviamo.
Per fortuna mi sento picchiettare su una spalla: M. mi sorride.
Giorno 12
Osservo i bordi della pizza d’asporto sul tavolo, i resti freddi di un pasto giunto già freddo. Il cartone è la tovaglia. Apro un’altra birra nella speranza che giunga una tregua all’ansia. Sono alla terza. Passerò la notte ad urinare, sognando nei minuti di dormiveglia situazioni legate al dover svuotare la vescica: piscio che non finisce più o impossibilità di soddisfare il bisogno, cessi che si aprono all’improvviso in cui succedono le cose più strane, dalle esplosioni alle inondazioni di merda dal pavimento. Anche i mie incubi ormai sono prevedibili, non ho più neanche un inconscio interessante, vista la banalità dei miei desideri. Non sono forse anche i vostri?
Cosa ci unisce in fondo? Il doverci liberare dalla fame, dalla sete, dalla paura?
Il dover pisciare, cacare, dormire, sfregarsi organi sessuali? Puzziamo tutti allo stesso modo, questo è innegabile. Abbiamo spesso gli stessi incubi. Ridotti all’osso della nostra psiche siamo rimasti poco differenti dai primi umanoidi. Bevo ancora. Lo stordimento fa fatica ad arrivare perché la mia mente ed il mio corpo fluttuano perennemente in uno stato di lucidità altra, un’ubriacatura da nulla, da assenza di senso. Spero che l’alcool mi dia una piccola possibilità di alterazione: soltanto un passo avanti nell’oblio, solo questo, come un’aggiunta di ovatta nelle orecchie.
Tracanno dalla lattina un altro abbondante sorso ma ottengo solo uno sgradevole retrogusto di bocca impastata. Lo stomaco comincia a non volerne più ma alla testa non arriva nulla, finirò solo per vomitare di questo passo.
Guardo l’orologio, quasi le 4.00 del mattino.
Provo ad accasciarmi sul letto ed inizio a pensare agli incubi che farò, li programmo, in modo da poterli gestire. Un’ ascensore che sfora il soffitto? L’essere inseguiti ed avere le gambe di piombo? La voglia di gridare e l’assenza di voce? Il mare nero che si gonfia e il cielo che ti cade addosso? I luoghi dell’infanzia? I morti?
Ecco, entro in un bagno pubblico col forte bisogno di pisciare, chiudo la porta, ma qualcuno bussa forte e la spalanca…
Giorno 13
Tra una fermata e l’altra di questa metro puzzolente ci sono pochi minuti. E mi sembrano secoli. Ho sempre l’impressione che questo treno per topi non si debba arrestare mai, che vada sparato verso chissà dove, all’infinito, per farci impazzire tutti, qua dentro.
Le facce assenti e stravolte dei miei compagni di viaggio non profetizzano nulla di buono: ogni volta che il motore riparte dopo il bip delle porte che si chiudono non ho la certezza che tutto vada bene, lo stridore sulle rotaie mi spappola il cervello; non ho la minima idea di come ci si possa sentire sicuri in questi convogli infernali.
C’è una ragazza visibilmente scossa, in pieno attacco di panico, che chiude gli occhi e respira profondamente. Ha appena preso delle gocce e bevuto un sorso d’acqua. Ha le mani strette sulle ginocchia e sembra in procinto di piangere. Nessuno se ne cura, lei è soltanto in uno stato di lucida consapevolezza, ha semplicemente dato una grattata alla superficie sgretolata della falsa tranquillità che mostriamo. Pan, la natura animale, la pungola da dentro le viscere: nessuna bestia ama essere intrappolata in lamiere sparate a folle velocità. So che non resisterà a lungo. Guarda l’orologio, si alza di scatto e decide di scendere, evidentemente, ad una fermata che non è la sua. Per poco il lembo della sua gonna verde acido non si incastra nelle porte automatiche del convoglio.
Ecco il nostro senso di sicurezza, questa sottile membrana tra il terrore latente e il rimbambimento quotidiano che cerca di soffocarlo.
Finalmente devo scendere anch’io. Mi accodo alle persone vomitate sulle banchine, a fiotti, cibo non digerito da questa città congestionata, ingozzata a forza come un’oca all’ingrasso. Una città come altre città.
Io, grumo di vomito in una pozza di vomito, terrificante ed in preda al terrore, nella morsa di Pan e con gli occhi all’orologio, alle incombenze, alle commissioni, agli stupidi impegni.
Devo comprarmi un altro telefonino. Ne devo avere almeno due. Uno per M., un altro per tutto il resto. Il resto? Che cosa è rimasto?
Giorno 14
La solitudine ormai fa parte delle mie ossa. Anche oggi, come ieri e come l’altro ieri e fino a quando non ricordo, non ho avuto nessun contatto umano e nessuna comunicazione. Ho ripetuto una decina di ciao al lavoro senza neppure alzare lo sguardo e ho ricevuto altrettante distratte risposte, forse uno stupido buongiorno da chissà chi. Ho attaccato con le manfrine telefoniche alle 8 del mattino e così fino al tardo pomeriggio. Ho chiesto il solito frugale pranzo alla barista annoiata che si è dimenticata persino l’ordinario prego.
Cerco di terminare questa giornata.
Decido di collegarmi al web. Vedo M. online, saluto. Ottengo una faccina. Ottengo un contatto, un’attenzione:
“Hey, hai mangiato?”
“Si, qualcosa.”
“Devi cercare di dormire, lo sai?”
“Si lo so.”
“Hai preso quelle pillole che ti ho consigliato?”
“Non ancora, ma lo farò.”
“Devi cercare di riposare, di essere in forma, se no…”
“Me lo hai già detto, ci proverò.”
“Bene. Hai preso l’altro cellulare?”
“Si, l’ho comprato ieri.”
“In quel negozio, vero?”
“Certo.”
“Bene. Fammi uno squillo. Ti chiamo appena possibile.”
“Ok. Fatto.”
“Ricevuto. Ora vado, ho del lavoro da sbrigare. Vai a dormire.”
“Ok, notte.”
“Notte.”
Mi stendo, chiudo gli occhi e vedo solo mostri, mostri e ancora mostri.
Giorno 15
Ho detto a M. che prendo i sonniferi ma in realtà ho comprato del whisky a buon mercato. Con un bicchiere riesco a perdere i sensi per un’oretta, poco dopo la mezzanotte. E’ già tanto.
M. mi aveva anche consigliato di prendere antidepressivi ma non l’ho fatto. Non credo di essere in preda alla depressione, sono allo stadio successivo: una lucida ed assurda disperazione, ho smesso di piangere, avverto qualche attimo di malinconia ma passa subito. Mi trovo a pochi passi dalla pace interiore, basta poco ormai, me la prefiguro, so che la raggiungerò e so bene come raggiungerla. Che aiuto potrebbero darmi quelle pillole? Indorare la vita di merda che conduco? E’ impossibile; nessun essere umano cosciente, dotato di consapevolezza, potrebbe affermare che vivere in questo modo sia piacevole. Vi suonerà strano ma ho una mente sana, sfuggo al masochismo e alla coprofagia che oliano gli ingranaggi di questo perverso meccanismo.
So bene quel che voglio, ma altri me lo hanno rubato, la mia deprivazione è la loro ricchezza, la mia sofferenza il loro benessere.
Ho una mente sana, come molti di voi.
Prendo un bicchiere dal fondo largo e pesante, lo riempio per metà con del whisky e bevo. Un leggero sollievo. Mi appendo al rubinetto dell’acqua perché l’alcool mi ha seccato la gola.
Accendo una sigaretta aspettando anche solo una mezz’ora di sonno: ho il cervello che proietta ventiquattro ore su ventiquattro, tipo un film di Lynch senza fine.
M. queste cose non le sa ed è meglio che non le sappia.
Ma in fondo che importa?
Giorno 16
M. ha detto di aspettare in chat. Ha delle cose da dirmi. Ho cenato con del tonno in scatola, aperto e mangiato direttamente nel barattolino con una forchetta appena sciacquata. La pila di stoviglie da lavare cresce da giorni dentro al lavabo. Non ho tempo per queste cose. Il progetto di M. affolla sottilmente i miei pensieri, dal momento in cui me lo ha esposto per bene, quel giorno in chiesa. Aspetto ogni sera sue comunicazioni. Raramente telefona.
Apro il social e nell’attesa cerco di far passare il tempo con un gioco online, qualcosa di stupido, che non mi faccia pesare l’ansia. Scelgo una cretinata con una pistola da giostrare col mouse e sparare a degli omini bianchi che passano velocemente sullo schermo. Colpiti, schizzano sangue dappertutto, se li prendi in testa crepano di botto con la caratteristica torsione del collo; sul ventre, si piegano in due e arrancano lentamente verso le salvifiche uscite laterali allo schermo. Se li becchi alle gambe, strisciano sul loro stesso sangue. In questi frangenti di lentezza, li puoi colpire ancora, uccidendoli definitivamente. Non ho limiti di proiettili, solo di tempo: la partita dura un minuto. È divertente, replico parecchie volte, non mi accorgo che è passata un’ora.
Sento il bip della chat a malapena: M. mi mi chiede se ci sono. Rispondo di sì, metto in pausa la sparatoria agli omini; mi digita un link, mi scrive che ha poco tempo e che le nostre comunicazioni d’ora in avanti dovranno passare per il “darkweb”. Dal link devo scaricare Tor e navigare con esso. Non ne capisco molto ma, ovviamente, replico che mi atterrò alle sue indicazioni. Mi spiega tutto, non sembra troppo difficile.
Tutti questo scrupoli mi sembrano eccessivi, ma è la mia incoscienza che non dà peso a questi dettagli, il mio non aver nulla da perdere, la mia scarsa convinzione.
Mi appisolo. Nello schermo dei miei occhi chiusi si proiettano omini bianchi che schizzano sangue sotto raffiche di colpi. Sono centinaia.
Giorno 17
Porte chiuse oggi alla compagnia telefonica. Sciopero selvaggio. Alcuni sindacalisti spiegano che ormai tutto volge verso il tracollo: si chiude baracca, siamo tutti nuovamente senza lavoro. Il teatrino di rito prevede questa inutile forma di protesta: qualche telecamera della tv locale si aggira tra il gruppetto di disperati raccogliendo le loro voci. Giornalisti sottopagati che pensano a salvarsi il culo e a concludere questo noioso servizio prima possibile.
Mi siedo ai margini, non ho nessuna voglia di vedere la mia faccia al prossimo telegiornale, per me non c’è nessuna sorpresa e non avrei alcuna dichiarazione da fare. Lo sapevo già, lo sapevamo tutti, i notiziari pullulano di situazioni simili. Vedo dei poliziotti in tenuta antisommossa, sono tranquilli, regna una rassegnazione proverbiale nelle facce di questi uomini e queste donne allo sbaraglio, senza niente da fare, senza alcuna speranza di miglioramento. Un sindacalista grida le solite stronzate al megafono: i padroni corrotti, il capitalismo becero, il governo che non fa nulla. Un mantra che conosciamo bene. Mi fisso su un disperato di mezz’età che piange, piegato sui tornelli. Grida che ha famiglia, che non sa cosa dire ai suoi figli, che sua moglie lo lascerà, che non potrà pagare il mutuo, che da tempo non può scaldare l’abitazione a dovere. Ha il volto paonazzo, i capelli radi, unti; gli occhi rossi, stanchi, la bocca incurvata in una smorfia di sconforto; indossa una felpa blu troppo grande, dei jeans logori e delle scarpe da ginnastica che hanno fatto lunga strada.
Grida, con le mani alla testa. Un poliziotto si avvicina per calmarlo; le telecamere, sciacalli del dolore, si fiondano su di lui che diventa il piatto forte della giornata. Ho un moto di disgusto. In questa triste rappresentazione sociale io sono dalla parte dell’uomo con la felpa blu, i nostri destini sono simili, siamo la feccia. L’umiliazione mi si ferma in gola, come un boccone mortale.
Respiro a fondo, ho ancora dei soldi da parte.
Giorno 18
Ho chiamato M.
Dopo il mio racconto su ciò che è successo alla compagnia telefonica non ha mostrato troppa preoccupazione, mi presterà dei soldi fino alla conclusione del nostro progetto, poi si vedrà. Intanto venderò la mia macchina, non so cosa farmene ora che non devo più raggiungere la periferia per quei quattro soldi al call center.
Ho spedito un curriculum ad una catena di fast food, prima o poi mi risponderanno. O no? Che importa?
Oggi, per la prima volta da chissà quando, non ho dovuto mettere la sveglia alle 5.75 del mattino. Non so se posso parlare di felicità. Anche in questo caso si tratta soltanto di assenza di pena, con un danno economico per giunta.
Decido comunque di godermi il momento. Fuori impazza una bufera di vento e pioggia quasi gelata. Rimango a guardare il soffitto, sotto le coperte. Niente traffico, niente cabinotti, niente tiritere da ripetere. Vorrei dormire, ma il sonno non giunge. La mia mente si svuota, il mio unico pensiero fisso è il bianco del soffitto, uno schermo spento. Che sia questa la felicità? Di sicuro ne è una forma. Sento il mio corpo fluttuare, staccarsi, sdoppiarsi. Sono sul soffitto, ma anche nel letto. Mi guardo e guardo me che guardo. Non è proprio una bella visione; la stanchezza, la miseria e lo sconforto hanno reso spiacevoli i tratti del mio viso, che pur male non dovevano essere, un tempo. Le mie membra magre sono quasi traslucide, sembrano tubi di neon. Non penso di aver mai posseduto la bellezza, se l’avessi avuta forse la risicata batteria di scelte di vita sarebbe stata più ampia. La bellezza, come un jolly nella mano di carte. Sempre sul soffitto, il mio terzo ego, non mi riconosce, non riconosce quel frattale sul letto. Quindi precipita, come una folgore, coi tratti del viso deformati in un ghigno estraneo, mi precipita addosso. Ovvero io precipito dall’interno. Così sembra. L’ego che ci osserva resta immobile, mi vedo soffocare con le mie stesse mani.
Giorno 19
Ho trovato un acquirente per la mia vecchia auto. Un tipo che gestisce uno sfasciacarrozze, molto probabilmente il mio macinino verrà smembrato per ricavarne pezzi di ricambio. Una donazione di organi. Questo simbolo di indipendenza mi mancherà un poco, ma ho bisogno di soldi per acquistare altra roba, altra “ferraglia”, così la chiama M. L’appuntamento è per le sette del mattino. Sono le tre e, tanto per cambiare, non chiudo occhio.
Decido di salutare con stile le mie quattro ruote. Bevo due bicchieri di whisky, e l’ebbrezza, ubriachezza a questo punto, non tarda a giungere. Sento la testa fare dei mezzi giri e poi tornare indietro, voglio precisarlo, non compie rivoluzioni complete, io non riesco a vedere dietro le mie spalle. Mi vesto alla buona e mi metto al volante. Lo sfasciacarrozze dista almeno un’oretta di guida. Le strade sono deserte e umide. I pochi semafori lampeggiano col giallo. Mi sparo ad una velocità di 100 km orari dove il cartello ne indica un limite di 40. Viaggio a cavallo sulla doppia linea bianca, zigzagando. Non c’è anima viva in giro. Imbocco dunque una strada fuori mano, di quelle piene di curve, col tunnel di alberi che pare minacciosamente calarti sugli occhi. Corro, corro, fino ai 150, abbaglianti spianati sul quasi nulla, sulla nebbiolina della notte. I miei riflessi, che dovrebbero essere obnubilati dalla mancanza di sonno e dall’alcool, sono in realtà più vigili di quanto immaginassi. Una specie di pilota automatico gestisce quelle curve assassine in modo esemplare, un pugno fantasma mi tiene lo stomaco che ad ogni deviazione del rettilineo pare voler balzare fuori dalla bocca. Non credo neanche di essere nella corsia giusta e molto probabilmente sto sbagliando strada. Se lo sapesse M. s’incazzerebbe di brutto.
Sbuco in una carreggiata più larga e con alcuni lampioni ai lati. Come per prendere la rincorsa, decelero. Ingoio un bolo di muco al sapore di whisky, premo sull’acceleratore, 170. Purtroppo il macinino inizia a barcollare. Devo fermarmi. L’alba fa già capolino. È molto bella, rosa ed arancione. Anche il mio vomito tende all’arancione. Sarà questa l’armonia con la natura che tanto si decanta?
Giorno 20
Ho appena lasciato la mia automobile e ritirato la misera controparte in denaro. Sono a piedi, in una zona che non conosco. Lo sfasciacarrozze mi dice che se ho bisogno di un passaggio c’è un carro attrezzi che torna in città, ma devo aspettare un’oretta. Preferisco avviarmi a piedi. Smaltirò la sbornia e la giornata è limpida. Mi faccio dare indicazioni. Devo macinare quasi sette kilometri prima di trovare una fermata di autobus. Non importa. Non ho nulla da fare. Non ho un lavoro e conosco il mio futuro. Vorrei spegnere i telefoni, ma M. mi vuole sempre rintracciabile, giorno e notte. Spero non chiami. Voglio camminare, ho bisogno di solitudine, ancora più solitudine, come se non fosse mai abbastanza. Eppure è immensa.
Decido di far pausa, verso metà strada. C’è un parco nel mezzo di un complesso di abitazioni, di nuova fattura, di quelli che sorgono alle periferie delle periferie, agli estremi dei Leviatani che si espandono. Mi siedo in una panchina, la tarda mattinata è un orario morto: i lavoratori sono già dentro le loro galere scelte, i bambini già rinchiusi tra le sbarre scolastiche, chi doveva portare fuori il cane di solito lo ha già fatto. Così, dappertutto.
Scorgo qualche vecchio e una coppia di giovinastri, spacciatori probabilmente. Gli unici individui fuori dai ranghi, quasi dei privilegiati.
Accendo una sigaretta. L’unica sorpresa è l’arrivo di una giovane mamma con un bambino a seguito. Chissà per quale astruso motivo quel pargolo non è a scuola ma felice con sua madre. Chiede di essere dondolato sull’altalena ed è inverosimile la luce di gioia che guizza nei suoi grandi occhi neri. Anche la sua giovane mamma sorride stancamente, non è felice, ma serena; spinge l’altalena leggermente con una mano mentre con l’altra striscia sul suo smartphone. Il piccolo è in estasi, si spinge in avanti per volare più in alto. Ha una polo bianca e dei jeans, i capelli lisci a caschetto, neri e lucidi come i suoi occhi. Ride di gusto, una risata vera, di quelle che solo i bambini sono capaci di produrre. Ricordo vagamente questa sensazione di gioia smisurata, devo averla provata anch’io, ma chissà quanto tempo fa.
Giorno 21
Aspetto M. in chat. Ho aperto il Tor da un’ora, è in ritardo. Di solito la sua puntualità è proverbiale. Gioco a sparare agli omini bianchi da 45 minuti ormai. Gli occhi sembrano storcersi di fronte al monitor, ho bevuto anche stasera, spero che M. non se ne accorga. Ha un diavolo di sesto senso che mi fa paura. Certe volte credo che mi annusi l’alito via web. Oppure sono i miei errori grammaticali a scatenare la sua paranoia? Eppure, nemmeno la sua scrittura è così corretta.
Ecco il bip…
“Venduta la macchina?”
“Si, non ci ho ricavato molto.”
“Basterà. Ti serve qualcosa?”
“Direi di no, ho dei soldi da parte, certo non per sempre.”
“Non ne avrai bisogno. I piani stanno accelerando, ci vediamo in questi giorni. Porta i soldi che hai. Domani devo incontrarmi col nostro fornitore.”
“Ok, aspetto tue comunicazioni.”
“Per il resto? Ora che non lavori riesci a dormire e a mangiare decentemente?”
“Si, va un po’ meglio.”
“Hai letto quel che ti ho mandato?”
“Non ancora, ci darò un’occhiata adesso, prima di addormentarmi.”
“Mi raccomando.”
Saluto e chiudo. Ho già la testa confusa e non ho alcuna voglia di leggere.
In realtà non dormo da tre giorni di fila e ho mangiato le solite scatolette fredde di tonno con del pane raffermo. Non so da dove provenga questa proverbiale apatia, un’anticamera della morte. Sono i malesseri a ricordarmi che sono ancora in vita, questo disagio continuo e diffuso.
Non ditemi che non mi capite.
Io lo so che anche voi provate queste cose.
Giorno 22
Giornata vuota. Nulla da fare. Il futuro del mondo: miliardi di nullafacenti che dovranno dividersi le briciole. Io sono il futuro. Come molti di voi.
Poltrisco in un letto sfatto, una mosca mi ronza attorno. Vorrei ucciderla e lei lo sa, mi legge nel pensiero e si sposta verso la solita pila di stoviglie da lavare.
Chiudo gli occhi. Da quanto tempo ormai non sento il mio corpo? Anni luce da quel che i miei simili chiamano affettività, sentimenti, amore; e non solo. Fuori anche da ogni altro tipo di commercio sessuale. Cani randagi se la passano meglio di me.
Il calore delle coperte mi aiuta. Senza gli estenuanti ritmi del lavoro concesso ai noi miserabili, il mio corpo sembra recuperare ancestrali energie. La mia mano scende giù, unico mezzo, essenziale prolungamento, per il conforto di un breve piacere. Lo schermo della mia mente è però spento. Pare sia doveroso proiettare qualcosa, una situazione, delle persone. Anche il porno svogliatamente visionato sul web mi è indifferente. Inizio con un movimento lento che è automatico, desideri troppo a lungo accantonati non riemergono rivolti all’altro. A chi? Chi mai ha alzato lo sguardo verso di me? Quando è successo l’ultima volta? Non ricordo. Forse nell’asfissia di un vagone di metropolitana, nello spazio vitale ormai ridotto all’osso, forse solo lì ho dovuto per forza di cose, approcciarmi al calore altrui. Ma certo questo non basta. Anzi, è un pensiero fastidioso, un’orgia non voluta.
Lo sfregamento meccanico continua, non si risolve, ma continua; il tempo passa, pensieri senza un filo logico si affollano nella mia mente, come gli stati ipnagogici pre-sonno. Non riesco a fissare un oggetto di desiderio preciso, non lo trovo. Non riesco ad immaginare chi mai possa desiderarmi.
La ferraglia di M.
Bisogna che vada a recuperarla.
I tempi stringono, è ora.
Deve avere un buon odore, quella ferraglia…
La mosca è tornata da me. La lascio stare.
Giorno 23
il cuore ha sobbalzato nel pieno della notte. Un allarme è rimasto azionato in strada e non smette di suonare. Mi sembra di dover impazzire da un momento all’altro. Passo una mezz’ora con gli occhi spalancati al buio. Questo suono sibilante non si arresta, com’è possibile, per tutto questo tempo? Caccio la testa sotto al cuscino e mi stringo forte le orecchie. La sirena continua ad ululare, in lontananza, e il suo fastidioso grido non si smorza, non si attutisce. Sudo freddo. Prendo dei tappi per le orecchie, in cera morbida. Li spingo a forza nei condotti uditivi. Nessun conforto. Che significa? Diamine!
L’allarme è dentro la mia testa! Risuona come una lama metallica e non c’è modo di farlo cessare. È dentro di me. Apro la finestra, ma in strada a quest’ora della notte regna il silenzio assoluto. Avrei avuto perlomeno confondere questo diabolico fischio, mischiarlo ad altro. Solo un remoto abbaiare di qualche minuto, in lontananza. Non mi rimane che la musica, qualcosa di forte da spararmi nelle orecchie con le cuffie. Apro il mio pc. Devo scegliere qualcosa di molto rumoroso, non importa cosa. Faccio una breve carrellata su youtube e scelgo dei pezzi Death Metal. Non che mi piaccia. Alzo il volume al massimo. Stranamente l’allarme riesce a confondersi, ma di certo la mia testa non ha pace. Pare che stia scoppiando. La batteria furiosa, le chitarre accavallate e distorte, la voce cavernosa di un cantante sconosciuto non mi rendono alcun piacere uditivo ma sono l’unico balsamo contro quel sibilo monocorde che rischia di portarmi al suicidio.
Mi vengono in mente le pillole che mi ha consigliato M., ne tengo una scatola nel cassetto, non si sa mai volesse controllare se le prendo.
Forse è giunto il momento di provarle. Ne ingoio un paio e, mentre il Death Metal mi rimbomba dentro, sento giungere un’ondata calma e tiepida, anche la razionalità comincia a far capolino nei miei pensieri. Acufeni, stress, sbalzi di pressione. Mangio poco, dormo quasi niente. È il minimo che possa capitare.
Chissà quanto è profondo l’abisso che mi separa da voi.
Giorno 24
M. deve consegnarmi la roba. Ho preso i miei risparmi, ho letto a volo d’uccello le cose che mi aveva dato da leggere, che ho trovato poco interessanti ma facili da memorizzare nel caso volesse interrogarmi. Spesso lo fa, ma con poca convinzione, senza starmi troppo addosso. Siamo in fondo distanti, reciprocamente indifferenti, come tutti voi, d’altronde. Guardatevi dentro: chiusi in una stanza con un vostro simile, con una pagnotta e un bicchier d’acqua, prigionieri per un mese, finireste per diventare cannibali, nel migliore dei casi. Torturatori o stupratori, allo stadio perfetto della malvagità. L’indifferenza reciproca è l’unico collante di una comunità, il bene assoluto che può circolare tra i suoi membri.
Aspetto nei pressi di un teatro, l’orario lo rende simile ad un luogo abbandonato, ma è aperto. Il mio strato sociale non mi ha mai permesso di bazzicare in luoghi come questo, non so nemmeno a cosa possano servire simili edifici. Al solito, sono in largo anticipo per l’appuntamento. Decido di entrare in questo luogo a me precluso, per pochi istanti. Nella hall non c’è nessuno, il bancone della biglietteria è deserto. Nell’atrio, le locandine del programma decantano Mozart, Verdi, Strauss… A malapena ricordo il nome del primo di questi personaggi. Scosto un attimo un tendone e mi si apre agli occhi l’interno: la platea, le logge, il palco, un lampadario immenso, un odore di stoffa e di polvere. E’ molto grande, più grande di quel che mi aspettavo.
Odo un forte rumore di lucidatrice farsi sempre più vicino. Un uomo col viso butterato mi redarguisce: “Cosa fa lei qui? Cerca qualcuno?”.
Dico solo che stavo dando un’occhiata all’edificio e ne decanto la bellezza. Lui sembra credermi ma non approfitto della sua ingenuità.
M. mi fa uno squillo ed è ora di uscire.
Prendo un flyer del programma. Tra poche ore, un certo Schubert. Mi verrebbe la curiosità di ascoltarlo. Provo a digitare il suo nome sullo smartphone connesso, ma M. è già qui con una custodia per strumento musicale.
Giorno 25
Fumo e bevo, e non dovrei. Ho dato tutto quel che avevo a M.
Ho una custodia di uno strumento musicale in casa. Non ricordo se violino, viola o violoncello. Io non ne so niente. Vorrei aprirla ma mi è stato vietato. Allora bevo ancora, vorrei sognare qualcosa di bello.
Un buon gusto, qualcosa di buono che si mangia senza troppa fame, che sia buono davvero, non perché stai svenendo dal digiuno.
Un buon odore, che non sia smog, spazzatura, merda agli angoli delle strade, chiazze di vomito sul marciapiede, i miei effluvi, che tanto non ho motivo di lavarmi.
Un bel suono, che non sia un allarme dentro al cervello. Non saprei, una musica che non ho mai ascoltato, che non mi dia fastidio.
Vorrei una carezza, il tatto. Non so bene cosa sia. Ho prurito ogni tanto, per ogni millimetro della mia pelle, forse per lo stress, per la cattiva alimentazione, per le cattive abitudini. Tocco del ferro e della plastica, i tasti del pc, striscio lo schermo dello smartphone, ecco, cose del genere. I tubi dell’autobus. Pulsanti dell’ascensore, della TV e quelli per aprire i portoni. Non percepisco nemmeno un fantasma che allunghi le sue dita su di me, magari per pietà (parola di cui non conosco il significato).
E vorrei vedere qualcosa di bello, non so, dei paesaggi, delle statue, dei quadri, delle opere d’arte; ma non riesco ad immaginare bene quali, non saprei davvero cosa ci possa essere di bello da vedere.
Vorrei almeno sognare queste cose, avere un’idea, seppur lontana, delle sensazioni che potrebbero restituire. Ma mi sono state negate.
Fumo e bevo, e questo è il mio unico conforto. Voi riuscite a fare di meglio? Voi intercettate frazioni di bellezza? Dove? In quale arcana dimensione? Percepite ondate di estasi? E come? Ditemi. Io vorrei saperlo, sarebbe la salvezza, la salvezza di tutti.
Giorno 26
M. mi sta telefonando. Non voglio rispondere. Ho la voce impastata dall’alcool e dalla veglia continua. Se ne accorgerebbe, lo so. Non che mi faccia troppe storie, so che ha bisogno di me, ormai. Non sono sostituibile, non fino a dopodomani. Apro la chat, inventando una paranoia sulla sicurezza delle comunicazioni.
“Scusa, ho sentito dei vicini, è meglio qua.”
“Ok. Hai suonato?”
“Non ancora.”
“Dovrai farlo o stasera o domani al massimo, in lucidità.”
“Si, me lo hai già detto.”
“Mi raccomando leggi bene le istruzioni, non vorrei che…”
“Non deve essere troppo difficile.”
“Se non si è pratici, è facile sbagliare qualcosa.”
“Mi avevi detto che avresti controllato.”
“Si, lo farò. Poco prima del concerto. Ma non abbiamo molto tempo.”
“Farò attenzione.”
“Devi riposare, devi essere nel pieno delle tue facoltà mentali e fisiche. Hai mangiato?”
“Si, mi sento a posto.”
“Se non riesci a chiudere occhio prendi una di quelle pillole, ti farà bene.”
“Lo farò, se necessario.”
“Bene. A domani.”
“A domani.”
Il domani? E’ già qua. Lo aspetterò ad occhi aperti, fissando il vuoto che mi sta davanti, il mio futuro. Il vostro futuro.
Giorno 27
Apro la custodia di quel che forse dovrebbe essere un violoncello. Lo scatto dei fermagli verso l’alto mi fa sussultare, chiudo e riapro, mi piace quel clic-clac. Non mi aspetto nessuna sorpresa. So già cosa contiene quell’involucro, lo so col pensiero, con la vista forse; ho scartabellato delle immagini sul web. Oggi voglio conoscere quest’oggetto con gli altri quattro sensi. E’ un AKM di fabbricazione russa, altro non so. M. mi ha lasciato dei foglietti con le istruzioni scritte e dei disegnini perfettamente intellegibili anche da un bambino: come montare il caricatore da 75 colpi, come inserire la sicura, stendere il calcio e agganciare la cinghia per l’imbracatura. Prendo in braccio questo aggeggio, pesa circa tre chili, mi sembra una piuma, il mio corpo organizza ogni singolo muscolo per accoglierlo, la forza si raggruma nei punti giusti, un’architettura perfetta. Lo annuso. L’odore ferroso mi dà alla testa, moltiplica l’energia che circola tra le vene. Lo tocco, in ogni sua scaffalatura, il calcio ampio, le levette segrete, il caricatore pesante, la canna fredda, il rompifiamma. Sfioro il grilletto. Brividi sconosciuti.
Il mirino. Ci guardo dentro, nel vuoto. Non ho mai sparato, M. ha detto che non serve alcuna esercitazione per questo caso. Ho un po’ paura dell’effetto del rinculo, deve essere potente. Stringo la cinghia a mia misura, tolgo e metto, con velocità. Mi piace il suono dell’incastro dei fermagli. Apro e chiudo la custodia, prendo l’AKM, lo imbraccio, con la cinghia. Uno, due e tre. Ripeto i passaggi. Mi sembra davvero troppo poco. Ma tutto andrà secondo i piani. L’AKM posizionato al fianco, premere il grilletto, tenere salde le gambe e la schiena, concentrare forza nelle spalle. Basterà? Devo riposare, poche ore mi separano dall’appuntamento. Mi accascio sul letto, il mio AKM con la canna sul cuscino, la lecco, ha un sapore ferroso, sembra sangue gelido. I rumori della notte si fanno più lievi, anche il mio respiro affannoso si regolarizza. Penso agli omini bianchi del videogioco online che stramazzano sotto il colpi del mio mouse, domani sarà più o meno così. Non c’è molto da imparare e poco da sapere. La pace interiore è molto semplice da raggiungere. Non so da quanto tempo non succede, ma mi addormento per poche ore.
Giorno 28
“Come va?”
“Bene. C’è solo questa musica che mi distrae.”
“Fai finta di non sentirla.”
“Mi piace. Che cos’è?”
“Un certo Strauss… Una canzone delle Alpi, o roba del genere.”
“Una canzone?”
“Non lo so, un’orchestra… Lascia perdere.”
“Che facciamo?”
“Sbuchiamo di botto da dietro l’orchestra.”
“E i musicisti?”
“Ascolteranno un ritmo diverso.”
Ho uno strano presentimento. Queste saranno le ultime parole di M. che sentirò nella mia vita. Vita? Quale vita? Avrò ancora vita fra poco? Seguitemi, voi state leggendo nel mio pensiero, cosa c’è di strano da capire? M. ed io rimaniamo con i nostri travestimenti da strumentisti. Che importa? Chi siamo? Non siamo niente. Io non sono niente. Proprio come voi. So che l’azione sarà molto rapida, il mio corpo sembra in preda ad una scossa elettrica, mi muovo a scatti e scopro una coordinazione psicofisica mai sperimentata prima. Ho un brutto sapore in bocca, asciutto e amaro : è l’adrenalina. Un rivolo di sudore freddo lungo la schiena, ma non mi preoccupa. Sono sotto controllo, ogni infima fibra di questo involucro che mi porto appresso è sotto controllo. Riesco a percepire il tragitto del respiro e quello del sangue. Le mie connessioni neuronali scoppiettano. Non sono niente e sarò tutto: resterò nella storia, nel mio anonimato, in questo fatale giorno. Oblio e ricordo indelebile, paradossalmente inscindibili. Stampa e social network saranno invasi dalla mia faccia, non mi importa più di tanto. E’ ora di agire.
Siamo nei camerini. Ci scambiamo le ultime occhiate. Nel giro di qualche attimo esisteremo soltanto nella nostra immensa solitudine. Noi e i nostri AKM, e null’altro. Imbrachiamo i fucili, M. mi controlla per l’ultima volta, fa un gesto d’assenso e mi abbandona. Ci separiamo, un angolo a testa del palco. Non ci rivedremo mai più.
Tasto il caricatore, l’indice ben piantato sul grilletto sembra bruciare, sul pollice si è concentrato un grumo di forza ignota, il calcio sotto al braccio; io sono l’AKM, i confini tra il mio corpo e quest’arma micidiale si affievoliscono, nulla intorno sembra esistere, io sono una dimensione a sé, una bolla deprivata sensorialmente. Dalla radice dei capelli fino al rompifiamma, io sono l’AKM. Alzo un attimo l’arma, stringo un occhio sul mirino, ma è una pura formalità: non ci sarà bisogno di prendere alcuna mira, la sala concerto è stipata, una pioggia di proiettili a caso sarà più che sufficiente.
Non riuscite a capirmi?
Sono dietro un tendone verde scuro. M. mi farà uno squillo nel momento in cui dovremo entrare in azione. Ho l’impressione di sentire in ogni attimo la vibrazione del cellulare dentro la tasca, una specie di visione sonora e tattile.
Respiro con regolarità, odo d’un tratto dei tromboni potenti che sembrano saltarmi dentro lo stomaco.
Il cellulare vibra, veramente adesso. Scosto il tendone, l’AKM è spianato, intravedo M., una frazione di secondo, o forse un secolo. Tutto mi gira dentro la testa ma in una lucidità mai conosciuta prima. È come l’amore, per quel poco che ricordo. Punto all’orchestra, parte la prima raffica. Uno che stava suonando una melodia all’oboe si accascia, mi guarda, ha gli occhi spalancati che sembrano dire non posso crederci. Gli sorrido e punto al direttore, cade come una pera matura. Dunque c’è la folla degli spettatori, M. ha già iniziato da due minuti, credo. Solo adesso mi rendo conto delle urla e del parapiglia generale. Sulle sedie coi cuscini rossi vedo già molti cadaveri, non me curo. C’è ancora molta carne che si muove, la punto. Raffiche e raffiche, tengo bene il rinculo, il mio corpo trema, trema in una specie di violento orgasmo, io sono l’AKM. Sento il sudore dietro la schiena, un lungo rivolo gelato. Mi volto, i musicisti sono quasi tutti scappati dietro ai tendoni. Non si può fare tutto. La musica è cambiata, ascolto questa sola nota, potentissima, ripetuta in frazioni di secondo, ha un suono secco e forte, non è ambigua, significa una sola cosa. Non ti puoi sbagliare.
Una violinista con una gonna verde acido è ferita alle gambe, giace ai piedi di una grancassa, non è riuscita a fuggire in tempo. Mi sembra di averla già vista, chissà quando, chissà dove, forse in un’altra vita. I suoi occhi sono il terrore puro, la capisco. Penso di sapere cosa si provi un attimo prima di morire, leggo questa sensazione nella sua mente, vittime e carnefici sono facce della stessa medaglia, hanno un cordone ombelicale invisibile che li unisce da sempre. La violinista si copre il volto con una mano e muore sotto i miei colpi, il suo cervello schizza sulla grancassa; mi è sembrato di percepire la vibrazione della membrana urtata dal grumo ma probabilmente è uno scherzo della sinestesia.
Sul palco non c’è più nessuno in vita.
Spiano l’AKM sulla platea, c’è ancora molto da fare. Non vedo più M., tutta la mia concentrazione si solidifica nei bersagli mobili rimasti, proprio come gli omini bianchi del mio gioco virtuale preferito. Le porte sono assediate, ammassi di carne inutile si spintonano, li freddo alle schiene, si accasciano, si lanciano gli uni contro gli altri. So che alcuni si stanno fingendo morti sotto i sedili; ammiro la vita, la sua ostinazione. Percepisco i loro respiri, ridotti al minimo, soffocati. Chissà come riescono a controllare il battito cardiaco, che deve essere pulsante, un cavallo impazzito dalla paura. Farei lo stesso? Sì forse sì, non tanto per la speranza di salvezza, quanto per sfida, una sfida personale. I loro ritmi tachicardici mi rimbombano in testa, non potranno sfuggirmi.
Nei pressi delle vie di fuga ci sono marmellate umane, una nube maleodorante comincia a prendermi a pugni: merda, piscio, vomiti, sangue. Avrei dovuto portare una mascherina, questi schifosi effluvi mi rovinano l’estasi. Anche le grida dei sopravvissuti sono insopportabili, ma vanno scemando. Muoiono a decine, qualcuno è riuscito a scappare. Non so quanto tempo è passato, il caricatore a 75 colpi è esaurito. Ho pochi secondi per ricaricare, in una frazione guardo l’orologio: ho sparato per otto minuti. Inizia il secondo round. Lo so che fra poco arriveranno le forze dell’ordine, lo so bene. Devo ottimizzare il tempo e i morti. Il mio cervello si attiva nel ricordo delle poche meccaniche mosse ripetute più volte: con un rumore secco il secondo caricatore si assesta nell’alloggiamento. Ho spinto con così tanta fermezza che mi duole il palmo della mano. Gli attimi di tregua hanno permesso ad alcuni di salvarsi. Il numero di prede comincia a diminuire. Riattacca la pioggia di proiettili, mi piace il loro suono, l’odore del propellente e il clack dei bossoli che si espellono.
Punto al lampadario, grandissimo, luminoso; premo il grilletto con forza. Un fracasso infernale di cristalli che schizzano via, grossi pezzi cadono al suolo e qualcuno urla: i finti morti, quegli animali in tanatosi che mi accingo a scovare, ad uno ad uno.
D’un tratto, il silenzio. Ho ucciso tutti quelli che potevo? Mi giunge l’eco confuso del trambusto fuori, le sirene lontane. Ho ancora dei colpi nell’AKM. Scendo tra i morti, mi si incollano le suole delle scarpe al pavimento: sangue viscido. Cerco chi è rimasto in vita. Il tempo scorre ma non ne ho una cognizione precisa, guardando l’orologio mi accorgo che il tutto è durato meno di quindici minuti.
Qualcuno piagnucola. E’ un uomo con una felpa blu e delle scarpe consunte. Punto la canna sulla sua fronte: non può essere venuto ad un concerto di musica classica vestito in questo modo, no, è uno che lavora qui, fa lo sguattero o cosa? L’ho già visto questo volto paonazzo: è quello che si era accasciato sui tornelli quando ha chiuso la merda di compagnia telefonica per cui lavoravo. Quello che gridava perché non aveva più da sfamare la sua famiglia. Che cazzo ti fai una famiglia in questo mondo di merda? Siamo quasi otto miliardi e non c’è più niente, niente per nessuno. Ora dice no no no ti prego no, e sparo. Tatatam! La sua faccia in poltiglia sembra una focaccia al pomodoro masticata dai cani. Vita inutile, come la mia. Non ho la presunzione di essere un qualcosa di unico, mi capite? Non sono niente. Provo a ricordare qualcosa di piacevole, di bello, di buono. Non trovo nulla. Disagi, malesseri, fatica, fame, insonnia, privazioni, insulti, indifferenza, rabbia: questo mi è stato concesso. Non mi sto giustificando. Io so che mi capite. Non c’è nulla di troppo difficile.
C’è silenzio. Con rammarico constato che ho ucciso quasi tutti. Guardare negli occhi le vittime prima di sparare mi piaceva, presagiva il mio futuro. Ma sono morti, tutti morti. Li prendo a calci, per sicurezza. C’è un bambino, ha i capelli lucidi nerissimi e gli occhi dello stesso colore, spalancati. È morto così. La sua felicità tranciata di botto, la sua polo bianca è zuppa di sangue. Mi sembra di averlo già visto, ma che importa? Lo scuoto. Eri felice, bimbo?
Forse ricordo qualcosa di simile alla felicità dell’infanzia: un raggio di sole che mi scaldava la guancia. Solo questo? Per il momento solo questo. Tutto il resto mi è stato rubato, o così percepisco: si chiama risentimento? Così chiamate questa rabbia sorda che non viene mai sopita? Cosa c’è da capire?
A questo bambino ho strappato la vita, anche a me è stata strappata la vita, in qualche modo. Non voglio giustificazione ma comprensione. Ci sono vite, come la mia, fatte di merda, perché altre sono fatte d’oro. Non ho altri mezzi per comunicare, se non questo AKM, questi proiettili. La mia firma è il sangue, non può essere altrimenti. Il mio nome sono questi morti, solo grazie a loro lo ricorderete.
Le sirene si fanno più insistenti, ma davvero mi stupisco del ritardo.
Immagino gli sbirri annoiati in centrale che ricevono una segnalazione d’allarme e pensano che due coglioni eravamo qua a giocare a CandyCrush. E devono mobilitarsi, tranquilli, non gliene frega niente, sono lì per soldi, come tutti. Avranno paura, come tutti. Si aizzano le teste di cuoio, certo. Prima che si organizzino qua abbiamo fatto tutto il possibile, tutto il danno possibile. M.chissà dov’è. Ci sono solo io. Mi aggiro ancora per i morti, pesto le loro frattaglie, schiaccio un pezzo d’intestino con la scarpa: esce un grumo di merda, schizza via, in faccia ad un altro cadavere. Cerco di carpire l’estrazione sociale di questo ammasso di defunti: vecchie ingioiellate, signori in giacca e cravatta ma anche gente comune, vestita alla buona. In fondo il prezzo del biglietto non era proibitivo e taluni ignoranti, come me, al giorno d’oggi possono permettersi di assistere a concerti di musica classica. Tutto fa brodo, qualcosa bisogna consumare. Mangi un hot dog a meno di un euro e vieni a sentire il signor Strauss. Democrazia. Tutti abbiamo diritto alla bellezza.
Per me è già tardi.
Stanno per venirmi a prendere. Vita o morte, la stessa cosa per me. Ho solo un grande bisogno adesso, dormire. Risalgo sul palco, mi accascio dietro al tendone, in un angolo di fili e cavi elettrici, tanto è saltato tutto. Stringo il mio AKM e scivolo tra le braccia di Morfeo, che non ricordo chi sia, una divinità del sonno, o roba simile. Sono ignorante. E mi chiedo: quanto sono difficili certe cose da capire?