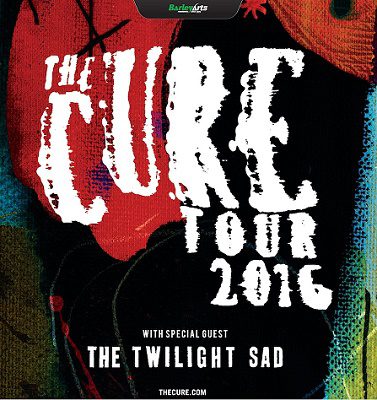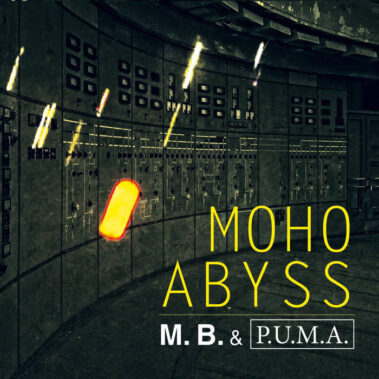Alle 4 di un pomeriggio assolato di Ottobre, l’EUR è candido di luce, monolitico e fascista come sempre, ma meno austero della Gotham City di Tim Burton a cui somiglia di notte. Di fronte al Palalottomatica molti di loro sono già in fila, stretti nei loro pantaloni neri, con i capelli cotonati, il rossetto sbavato, l’ombretto generoso e l’eyeliner. Nonostante l’uso massiccio di make-up sono sia maschi che femmine, hanno un’età indecifrabile e non si danno confidenza, nemmeno tra di loro. Un bagarino napoletano se ne lamenta e mi dice che i fan dei The Cure non sorridono mai: cerca da me solidarietà e biglietti in avanzo; non ho né l’uno né l’altro da dargli, ed oltretutto non sorrido, così se ne va sconsolato.
Il sole tramonta in lontananza su Ostia Beach e la temperatura s’abbassa notevolmente rendendo la coda infreddolita oltre che silenziosa. Alle 18,30 si aprono i cancelli ma in pochi corrono per guadagnare la prima fila. Gli altri camminano con andatura incerta ma solenne, guardando quelli che corrono con pietà e tenerezza. Dopo mezzora sale sul palco il gruppo spalla, The Twilight Sad. In pochi sembrano conoscerli, ma si ha l’impressione che in molti li andranno ad ascoltare nei prossimi giorni: sono bravi e malinconici; in più il cantante si muove così spasmodico da sembrare epilettico. Non pensare a Ian Curtis è praticamente impossibile. I Twiligth Sad raccolgono con discrezione la loro dose massiccia di applausi e lasciano il palco ai tecnici per l’ultima fase del sound check.
“ph. Annalisa Di Giuseppe / The Cure – Live a Roma”
Le luci si spengono e Shake dog shake riempie l’aria del palazzetto. Il primo pensiero che ho è che l’acustica è meno peggio di quella che mi aspettassi (e che mi avevano minacciosamente promesso) e questo mi solleva dai sensi di colpa per aver speso così tanto per un concerto in un palasport. I The Cure non sono diventati The Cure per la loro logorrea e così le canzoni filano via una dopo l’altra, senza presentazioni ampollose o ringraziamenti prolissi: Smith beve un sorso di birra, prende in mano un’altra chitarra (su una c’è scritta inspiegabilmente la sequenza di Fibonacci) e si rimette a lavoro. È un professionista e come tale va avanti per tre ore, suona tutte le canzoni e guida la band con pochi cenni, uomo solo al comando di una macchina che andrebbe avanti anche, o forse soprattutto, a fari spenti nel buio. Friday I’m in Love, Boys Don’t Cry e Close to Me sembrano chiudere il concerto quando l’ultimo pezzo (Why Can’t I Be You?) spiazza la platea, stanca ed appagata.
Si accendono quindi le luci, tra gli applausi riconoscenti per un concerto lungo ed intenso. In quel momento capisco che Robert Smith è l’essenza di tutto quello che ho visto finora: Robert Smith è l’inquietudine, è Edward Mani di Forbice, è l’essere dark, è l’invecchiare male, è la matita per gli occhi, è Sean Penn in “This must be the place”, è l’adolescenza di chi non è più adolescente, è la lingua che toglie il rossetto dai denti, è la coerenza con se stessi e con il proprio pubblico.
Robert Smith è la risposta vivente al “cosa resterà di questi anni ’80?” e di questo gli siamo tutti grati.