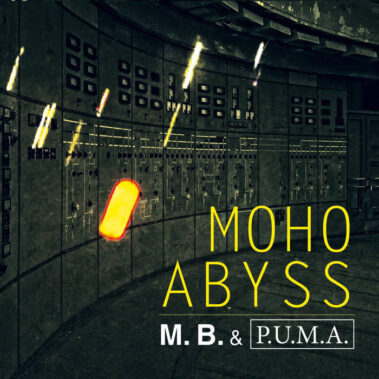Fin dall’inizio, fin dalle prime immagini devastanti che vedevo arrivare da Gaza, il mio pensiero è stato subito verso le donne. Continuavo a chiedermi come potessero superare i giorni delle mestruazioni, ad esempio, giorni che io spesso faccio fatica ad affrontare circondata da tutti i servizi di cui ho bisogno. E se qualcuna soffrisse di malattie all’utero simile a quella che ho avuto anni fa? E le ragazzine alle prese con le prime mestruazioni?
Ho pensato ai dolori. Se devi scappare prendi la borsa di tutti i giorni, quella con dentro il portafoglio, gli occhiali da sole, fazzoletti, magari un paio di assorbenti sempre a portata e forse mezzo blister di pastiglie di antidolorifico, ma poi?
Con il passare delle settimane il problema principale si è rivelato la mancanza di acqua potabile e di conseguenza come badare alla propria igiene intima.
A oggi più di un milione di donne e ragazze non hanno accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici così come li conosciamo noi. E soprattutto mancano gli assorbenti: ne servirebbero almeno 10 milioni al mese per le 690 mila donne interessate, 540 mila delle quali in età riproduttiva. Questa mancanza aggrava la loro salute fisica e psicologica. Addirittura un gruppo di donne ha iniziato a creare assorbenti con il tessuto delle tende. Molte donne sono arrivate alla decisione di prendere una pastiglia per bloccare il proprio ciclo mestruale.
E le donne incinte?
Più di 60 mila donne incinte nella Striscia di Gaza soffrono di malnutrizione, disidratazione e mancanza di assistenza sanitaria adeguata. Aborti spontanei dovuti alla paura data dai continui attacchi e dai continui sfollamenti. Parti in condizioni igieniche disastrose, difficili da descrivere. Le Nazioni Unite affermano che fra i 39 mila morti ufficiali, ci sono almeno 12 mila donne e fra queste 6 mila madri che hanno lasciato orfani 21 mila bambini.
La prima volta che sono venuta a conoscenza della famiglia Abo Ghanem è stata intorno a febbraio 2024. La pagina che già seguivo del Gaza Surf Club pubblicava un post nel quale mostrava la raccolta fondi di Rawand Abo Ghanem. Ho condiviso la sua storia e abbiamo iniziato a parlare. Lei, insieme ai suoi tre fratelli e una sorella, con i loro genitori, in quel momento si trovava a Rafah, sfollati dal nord della Striscia dopo aver lasciato la loro casa bombardata.
Rawand è una delle prime surfiste donne di Gaza, con lei anche sua sorella Kholoud e le cugine Sabah e Shoruq. Si può proprio dire che viene da una famiglia composta interamente da surfisti oltre che pescatori e bagnini. Jawad Abo Ghanem, papà di Rawand, e suo fratello Rajab, papà di Sabah, sono stati i primi surfisti. C’è un video in rete nel quale si vede Jawad prendere un’onda con il suo Hasake, una tavola tipica della regione che viene usata dai pescatori per tirare fuori dall’acqua le reti da pesca, oltre che, appunto, per surfare. E anche i fratelli di Rawand Yousef, Abdullah e Mohammed e il cugino Mahamed, fratello di Sabah, praticano surf.
Proprio una sorella di Rawand, la surfista Kholoud, è dall’inizio di questo massacro intrappolata nel nord di Gaza. Di recente in una telefonata con Rawand, alla domanda come stai, ha risposto che ha fame. La parte nord della Striscia è stata colpita duramente fin da subito sia negli attacchi che dal blocco degli aiuti umanitari.
A Rafah erano sfollati in una scuola UNRWA. Esatto proprio una scuola delle Nazioni Unite. La connessione non era perfetta, ma era abbastanza buona da poter scambiare quotidianamente foto, video e vocali. Non è stata una forzatura o un gesto di “buona azione”, è avvenuto tutto in modo spontaneo e naturale, come se avessi trovato una cara vecchia amica. La costante nei vocali che ci scambiavamo era il maledetto zanana. È un termine arabo usato dai palestinesi nella Striscia di Gaza per indicare il “ronzio”, quel terribile rumore prodotto dai droni israeliani nel cielo. Spesso il suono era così forte che non riuscivo a sentire la sua voce. Ma ci sono stati alcuni giorni nei quali quel rumore non si sentiva affatto e non esagero se vi dico che sono stati giorni nei quali la mia ansia ha raggiunto livelli molto alti. “Finché si sente lo possiamo controllare, ma quando non si sente più, non sappiamo cosa potrà accadere e molto spesso preannuncia un attacco”. Con il ronzio nella testa facevo fatica ad addormentarmi, io, comoda in casa mia, con un bagno pulito e acqua potabile sempre disponibile, ma lei? Loro? Ho imparato a conoscere quella scuola, il colore ocra della struttura, l’ampio cortile, l’edificio basso davanti alla classe/camera di Rawand e la sua famiglia.
Philippe Lazzarini, Commissario generale dell’UNRWA, ha dichiarato che due terzi delle scuole dell’agenzia nella Striscia di Gaza sono state bombardate da Israele durante la guerra in corso. “Le scuole sono passate da luoghi sicuri di istruzione e speranza per i bambini, a rifugi sovraffollati, e spesso finiscono per essere un luogo di morte e miseria”.
In nove giorni in questo mese di luglio 2024 a Gaza sono state colpite sei scuole.
Rawand e la sua famiglia dagli inizi di maggio hanno dovuto affrontare l’ennesimo sfollamento per l’ottava o nona volta. Ora sono nella zona “sicura” di Al Mawasi, con la loro tenda vicino al mare. Detta così sembra una gita, e lei è meravigliosa. Distrutta, ma davvero, non so dove riesca a prendere tutta questa forza. La voce negli ultimi vocali, sempre più rari a causa della scarsa connessione, è spezzata, ma il suo legame con quella terra è unico e speciale, difficile da immaginare. Perché quei 365 km2 sono tutto il suo mondo, ogni singolo angolo di quella terra è tutto ciò che hanno, tutto è lì.
Proprio oggi, mentre sto scrivendo queste righe, in questo sabato mattina dal tempo instabile, come se ci fosse una connessione tra la natura e lo scorrere degli eventi, lo stato di Israele, attraverso il suo esercito che si definisce “il più democratico”, ha appena attaccato l’area di Al Mawasi, Khan Yunis. Composta interamente da sfollati, chi con le loro tende, chi per strada. Sono state uccise 90 persone, metà delle quali donne e bambini e 300 sono i feriti. Tutti scavano nella sabbia per estrarre i corpi. Quella bella sabbia che descrive bene Mahmoud Alryashi alla fine del film Gaza Surf Club.
Le ragazze Abu Ghanem hanno imparato prima a nuotare che a stare in piedi. L’acqua è il loro elemento. Anche in questa tragedia terribile, Rawand e Sabah, in zone diverse della Striscia, appena hanno potuto, hanno portato i loro figli in spiaggia per fare un bagno e si sono tuffate anche loro. È un tuffo liberatorio, è un tornare alle origini, anche solo per pochi istanti.
Nel film, la Sabah quindicenne rivede un video di una sua intervista di quando aveva undici anni, sorride guardandosi. È con sua sorella e le sue cugine, si divertono tra le onde, si sentono libere. Dice che quando sarà più grande e diventerà un dottore, la comunità non permetterà loro di surfare perché considerato vergognoso. La sorella più grande, che ha sedici anni, non può né surfare né nuotare. Tornando al documentario, Sabah, ora sedicenne, indossa l’hijab. Il papà spiega che se le ragazze andassero in acqua ora, le persone si precipiterebbero a fissarle. “Quando le ragazze surfavano ancora erano i giorni più belli, potevamo nuotare senza che nessuno interferisse. Oggi è diverso. Ci controllano nel mare e in tutto il resto. Dicono che le ragazze non possono surfare perché considerato un peccato, una disgrazia” afferma Rajab. Non parlano di divieti che vengono direttamente dalla religione, ma più di convenzione, di qualcosa che non è accettabile dalla società in quanto parte di una tradizione.
Nell’estate 2010 l’associazione Surfing 4 Peace portando le famose tavole dentro la Striscia, si imbatte in visi nuovi, erano, appunto le quattro cugine.
Prima di quella estate le ragazze avevano già iniziato a surfare usando una vecchia tavola da windsurf e la tavola da surf del fratello Yousef, una delle tavole donate nel 2007. Era chiaro quindi che servissero delle tavole per queste ragazze.
In realtà fu un altro l’ostacolo principale al loro sogno di poter surfare. Rawand e Shoruq, le più grandi, erano più preoccupate per la mancanza di abiti adeguati, visto gli standard sociali conservatori. A Gaza non esisteva un costume islamico, così le donne nuotavano completamente vestite.
Sabah racconterà che una volta, mentre nuotava, l’hijab le si è avvolto intorno al collo, quasi soffocandola, così lo ha legato alla vita. È stata accusata da alcuni famigliari di aver fatto una cosa proibita, la sua risposta fu che erano affari suoi e che era una sua decisione personale.
Con il passare dei mesi ogni gruppo di sorelle aveva una propria tavola.
Ma il problema burkini, costume islamico, rimaneva. Così grazie all’interazione di Matt Olsen, direttore di Explore Corps, un gruppo di studenti di fashion design di New York si mise al lavoro per creare i costumi da bagno islamici. Furono così cuciti i costumi per Rawand e Shoruq. Inoltre, la Quicksilver Foundation donò una nuova muta Roxy per ogni ragazza di Gaza, così da permettere loro di surfare anche durante l’inverno. Il Wahine Project, un’organizzazione creata per aiutare giovani ragazze in difficoltà e permettere loro di fare surf, spedì pacchetti con vestiti, accessori vari e lettere piene di parole di incoraggiamento da parte di giovani surfiste dall’altra parte del mondo.
Le fotografie di quei giorni sono emozionanti. C’è soddisfazione negli occhi delle ragazze e grande consapevolezza di far parte di un momento unico.
Per molti occidentali, senza distinzione di sesso, è inconcepibile vedere delle donne vestire l’hijab o, come qualcuno dice, “addirittura”, il burqa. Mi ronzano nell’orecchio le vostre affermazioni così risolute, così perentorie, della serie “si fa come facciamo noi, perché solo il nostro modo è quello giusto”. Vi ascolto arrivare a conclusioni dall’alto di quella che consideriamo la nostra libertà. Ma è davvero libertà la nostra? Nel senso più limpido del termine? O è solo una visione corrotta della vera libertà? Siamo sicuri che stiamo usando bene il nostro privilegio quando si tratta di parlare di Palestina e di donne palestinesi?
A Gaza non c’è libertà, ciò che vediamo è frutto dell’occupazione che ha conseguenze in ogni ambito di quella società. Non ci sarebbe Hamas così come è, se non fosse per l’occupazione.
La pesca, ad esempio, prima era possibile a 20/30 miglia nautiche, perciò era facile pescare, ma poi loro l’hanno portata dalle 3 alle 6 miglia e così non si è potuto più pescare come prima. Loro, gli israeliani, decidono quante calorie può assumere ogni abitante di Gaza, si tratta di 2279 calorie giornaliere, e sappiamo bene che per alcuni israeliani sono anche troppe!
Allora mi chiedo, ma chi sono io, chi siamo noi, per giudicare.
È vero, fino a qualche tempo fa non era permesso alle donne di partecipare agli sport, ad esempio, sempre come convenzione sociale, ma da qualche anno è possibile. Sabah può criticare, Sabah può scegliere di non seguire la tradizione. A dire il vero non mi importa proprio giudicare, dall’alto del mio privilegio bianco. Non me la sento, perché prima di tutto tengo alla vita di queste ragazze e ragazzi, di queste famiglie, tutte, in quanto esseri umani.
Una delle persone che vorrei tanto conoscere prima o poi, Leila Khaled, politica e attivista palestinese, protagonista di due dirottamenti di aerei di linea nel 1969 e nel 1970 e membro del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, in una intervista dichiara: “non possiamo ottenere i nostri diritti se ancora difendiamo il nostro diritto ad esistere come esseri umani”.
E noi? Nel nostro occidente privilegiato e libero, quante battaglie noi donne dobbiamo ancora vincere e a quante ancora stiamo lottando?
“Uomini e donne sono nella battaglia per la liberazione”, sempre Leila Khaled
Come un ragazzo della resistenza dice in un video: “non vorrei combattere, vorrei solo andare a vedere il mare”. Anche Sabah sogna. Il suo sogno è quello di viaggiare all’estero e diventare famosa a Gaza, come quegli attori egiziani a cui la gente chiede loro gli autografi.