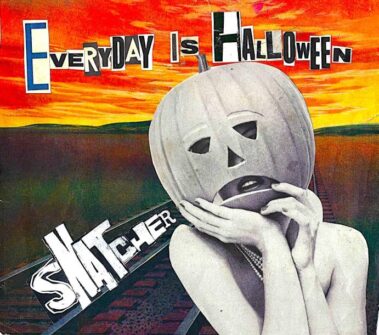Che cosa succede allora? Prezzi troppo alti, disinteresse, troppa concorrenza? Niente di tutto ciò. Il problema, come spesso accade, è alla radice: la musica.
Non si investe più su una programmazione organica, sui piccoli palchi, sulla pluralità di offerte. Si trasforma un festival “alternativo” (da 19 anni, prima che lo fossero in moltissimi) in un raduno di vacanzieri inglesi, incantati dal pessimo mare che comunque sembra Tahiti al cospetto di Brighton, interessati a godersi una settimana di relax e al massimo tre concerti per sera. Si buttano giù quattro ottimi Headliner, seguiti però da una serie risicata di ospiti di terza fascia, utili per lo più a riempire i tempi morti. Si riduce il numero di artisti del 70%. Si scelgono David Guetta e Mika, senza riflettere sul fatto che gli anni precedenti gli stessi palchi avessero ospitato Depeche Mode, Pixies, LCD Soundsystem, Chk Chk Chk. Insomma, si ragiona come tutti i festival che hanno fallito in Italia negli ultimi 3 anni.
Nonostante il deserto iniziale, tocca ai Toundra aprire le danze. Interessante quartetto strumentale di Madrid a cavallo tra quel post-metal affine ai Neurosis e il classico post-rock di Mogway e Pelican, non temono il palco Maravilla e coinvolgono per entusiasmo e disinvoltura, pur restando (per ora) distanti anni luce per suoni e creatività dai loro maestri sopra citati.
Si potrebbe fare lo stesso discorso per i Temples, che vantano qualche chance di successo in più solo perché britannici. Band iper-derivativa alla “Nuggets”, con enormi influenze misticheggianti e indianeggianti che qualche anno fa appartenevano a Kula Shaker e Kasabian e ora sono proprie di Tame Impala e affini. Parlo di chitarre Rickenbacker affogate nei riverberi, giri pop a presa rapida e la classica indolenza live tipica del movimento tardo hipster. Tutto già visto, piacevoli solo per aspettare il primo gruppone della serata, gli And So I Watch You From Afar.
Premetto subito che considero il loro “All Hail Bright Futures” uno dei dischi dell’anno, quindi mi vien difficile scrivere in maniera imparziale. E’ comunque oggettivo che l’esplosione live della band di Belfast abbia dell’incredibile: un set interamente strumentale, muscolare e variopinto, con combinazioni stilistiche che spaziano dalle morbide atmosfere care agli Explosions in the Sky alle cavalcate rock dei Trail of Dead, e perché no anche dei Led Zeppelin. “Don’t waste things..”, unico pezzo cantato nell’album, viene scandito unicamente dal coro del pubblico, il chitarrista (chiaramente leader della band) si divide tra flemmatici arpeggi e drammatici riff tanto cari al post-sludge dei Mastodon. Gli ASIWYFA costituiscono la band che meglio riesce a coniugare la destrutturalizzazione minimale del math rock con la rotonda pomposità del post-rock, lavorando continuamente per aggiunte e sottrazioni, e allo stesso tempo divertendo e facendo saltare il pubblico. Una band unica, affiatatissima, la prima fantastica esibizione del festival.
Il dream pop dei Beach House, al contrario, è soporifero e soffre dell’ incerto ultimo album “Bloom”. Come in altri live, le dolci atmosfere del “duo allargato” di Baltimora non riescono a colpire per efficacia, nel loro ondeggiante mix dilatato di tastiere suggellate dalla seppur ottima voce di Victoria Legrand. I brani di Teen Dream, come “Walk in the Park” e “Norway” se la cavano decisamente meglio, ma il pubblico di Benicassim ormai sta aspettando i Queens of the Stone Age: troppo lontani, troppo diretti, troppo tutto.
La dichiarazione d’intenti della band di Josh Homme è più che chiara: nel silenzio più totale, il megaschermo proietta video di vetri che si rompono ad intermittenza. Il quintetto imbraccia gli strumenti e inzia lo show: “Feel Good Hit of the Summer”, giusto per far saltare via qualche decina di cellulari (tra cui il mio, ovviamente) e iniziare a non toccare più per terra con i piedi. La clip di “Rehab” della Winehouse all’interno del brano rende tutto un po’ più chiaro, nel caso non lo fosse già. Insomma, i ragazzi continuano a fare da cattivi, e credo nessuno avesse dubbi a riguardo. Il concerto decolla con “Millionaire”, che non soffre della mancanza di Nick Olivieri, ed esplode con la recente “My God Is the Sun”. Seguono “Burn the Witch” e “Sick Sick sick”, in un crescendo di una perfezione disarmante, senza una minima pausa, violento quanto intimo. Homme non apre bocca per tutto il set, se escludiamo qualche insulto (con sputi annessi) alla security che cerca di impedire il crowd-surfing. Attitudine punk anche nei duri suoni di chitarra, più incentrati sui riff che verso gli slide delle “desert sessions”. Scaletta muscolare, ben calibrata tra vecchi classici (imponente il mix tra “You Think I Ain’t Worth a Dollar” e “No One Knows”) e nuovi brani dal recente “….Like Clockwork”, primo nelle chart americane fino a poco tempo fa. Ma quello che affascina di più è il continuum tra brani diametralmente opposti, che soddisfano diverse sensibilità musicali. Si passa dall’intimità di “I Appear Missing” alle ipnotiche ritmiche di “Keep your eyes Peeled”, suggellate da una esplosione di chitarre stoner. Josh Homme è meno sfrontato rispetto agli anni passati, meno showman e più direttore d’orchestra. I quattro mesi di riabilitazione da una profonda depressione vengono sfogati sul palco, a testa bassa, con il benestare degli enormi corvi neri appollaiati nello schermo retrostante. La conclusione è affidata a “Go with the Flow”, volano in aria fiumi di birra, si ha la sensazione di aver assistito a qualcosa di grande, molto grande.
“It’s the Queens of the Stone Age, we’re here to do whatever the fuck we want”. Forse bastavano queste parole di Josh Homme, come recensione.