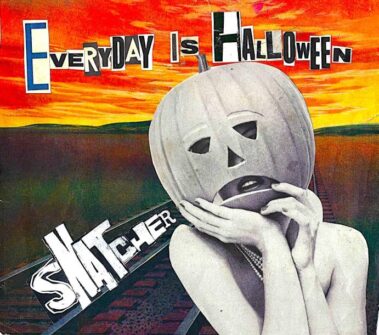Il meteo era pessimo quest’anno all’ArcTanGent. Era pessimo per gli inglesi, figuriamoci per un sardo. Non vedevo tanto fango in un concerto dalla videocassetta di Woodstock ’94. I Primus cantavano “My Name Is Mud”, e per qualche ora, in tenda, ho pensato si riferissero a me.
Sono stato al festival post-rock più importante d’Europa, organizzato da 3 (tre) ragazzi dei dintorni di Bristol che, in mezzo a noi comuni mortali, si riconoscevano perché si spostavano tra i palchi tramite un trattore (se non è DIY questo, non so cosa lo sia). Inoltre sulla testa di Goc, la mia referente stampa, insisteva un cappello contornato da girasoli, in quello che potrei considerare uno stile bucolico tardo hippie e che ero solito osservare, di contrasto, mentre ascoltavo le esibizioni più cupe del festival.
Dopo aver espletato i doveri del campeggio, mi rendo conto quanto i cinque palchi siano vicini tra loro seppur senza che si verifichi la minima interferenza sonora. Bene. I chioschi per rifocillarsi sono vari e numerosi, come i cestini per la differenziata e i bagni chimici. Ci sono anche cinquemila cuffie per la silent disco, tutti son gentilissimi e i palchi sono coperti anche nello spazio riservato al pubblico.
Unica dimenticanza: Goc, in mezzo a tanti grattacapi, non ha spuntato la casella “docce”, quindi, inevitabilmente, si affronta il festival nella migliore tradizione anglosassone: sette mila persone non fanno la doccia per tre giorni.
Giovedi 28 agosto
Il giorno inaugurale tutte le band si esibiscono sullo stesso palco, lo Yokay.
I TTNG (una volta This Town Needs Guns), scaldano il pubblico col loro math melodico, costruito su isterici arpeggi di chitarra e vocalizzi che paiono quasi stonati tanto sono imprevedibili. Sufficienti ma non coinvolgenti, forse penalizzati da suoni poco caldi, lasciano spazio ai Nordic Giants, duo di Brighton nascosto dietro enormi maschere da lupi, il cui set è accompagnato dalla proiezione di una serie di video che amplificano l’effetto scenico della performance.
Ripetitive e minimali basi di synth, prima soavi e poi violente, si fondono con una batteria ossessiva e incalzante, in cui le parti vocali sono affidate a sample puntuali e mai ridondanti.
I Three Trapped Tigers, veramente notevoli, propongono un drone rock più leggero, partendo dai primi Oneida e dai Lightning Bolt arrivano fino ad asciutte derivazioni di Aphex Twin.
Ultima band del giorno, i nordirlandesi And So I Watch You From Afar, che ancora più a loro agio in un palco così intimo, trascinano con le ormai classiche Big Things Do RemarkableThings, la caotica ed energica Like a Mouse e l’anthem finale The Stay Golden, accompagnato da un lungo coro di “We Know, we Know”. Tra stagedivers, braccia alzate e ampli Orange mandati in saturazione.
Il concerto della giornata.
Venerdi 29 agosto
Si inizia subito col botto.
Gli svedesi Ef, per me band sconosciuta, di nero vestiti calcano il grande palco Arc con mirabili fraseggi di chitarra e aperture orchestrali degne degli Explosions in the Sky, e tra quiete iterazioni cameristiche e fragorose deflagrazioni deliziano il pubblico inaugurando nel migliore dei modi la serata a venire.
Gli Enemies suonano un brit pop fresco quanto adolescenziale, i Tera Melos sullo stesso palco paiono molto meno precisi che su disco.
Il caos chitarristico e il noise generato da loop continui e rullate incessanti fa perdere un po’ di groove all’intera esibizione, comunque intensa, del trio di Sacramento.
Inizia a piovere sul serio, ci si barrica sotto i This Will Destroy You e si azzecca la scelta: sarà la band del giorno, e probabilmente il loro Another Language uno degli album dell’anno.
Uno spettacolo mozzafiato, iniziato in sordina e cresciuto nelle dinamiche fino a superare il rumore della tormenta esterna al tendone, quasi a cullarci e proteggerci.
La carica delle esplosioni tocca territori ai confini con il noise e lo sludge, impastando al generale suono plumbeo distorsioni laceranti care ai Cult of Luna.
Un gioiello che rimarrà nella memoria di chi ha vissuto questo memorabile show. Chiamatelo doom, shoegaze, drone, post rock, oppure semplicemente “concerto capolavoro”, questo han prodotto i TWDI.
La scelta dell’artista successivo è obbligata: l’acquazzone biblico che imperversa su Fernhill Farm costringe a restare bloccati sotto il main stage, aspettando gli headliners americani Russian Circles e perdendo (ahimè) i Maybeshewill.
Anche qui le texture di distorsioni sono imponenti, ma lo sguardo si volge verso gli accordi in tonalità minori tipici del black metal più classico.
Se il loro ultimo lavoro Memorial rappresenta il loro climax migliore, la resa live ne amplifica il drumming tribale e quindi la tensione emotiva.
E tutto il concerto è marcato, a momenti alterni, da episodi di chiaroscuro, oscillanti tra la durezza del metal e lo speranzoso abbandono nel post-rock.
Il finale è talmente intenso che cala anche la pioggia, o forse mi sento più ottimista, ed impaziente mi preparo per l’ultima serata di live.
Sabato 30 agosto
Mylets è il nome che sta dietro un imberbe diciannovenne americano, Henry Kohen, che grazie ad un prodigioso uso dei loop di chitarra e degli overdub riesce da solo a suonare come un intero gruppo.
Le ispirazioni sono sicuramente il pop sbilenco dei Maps and Atlases e una certa attenzione al prog energico dei Mars Volta, e il risultato è un apprezzatissimo set pomeridiano che apre la strada ai Tall Ships, trio (allargato ormai a cinque elementi) di Brighton che si esibisce sull’opposto palco Arc.
Si inizia con T=0, un riff che si ripete allo spasmo su cui il cantante Ric Phethean sospira una trama di voce delicata quanto struggente.
I Tall Ships (come gli Enemies) sono probabilmente fuori contesto in questo festival, tra romantici sintetizzatori, battiti di mani, delicati flutti di chitarre, ma ne incarnano l’aspetto più soavemente coinvolgente.
Quando Ode To The Ancestors, tratta dall’album EverythingTouching, viene dedicata a due ragazzi che si fidanzano sotto il palco, sembra che in questo lungo pomeriggio tutto si fermi, e si crei una magia ipnotica e rarefatta, il miglior preludio alla fantastica Phosphorescence in cui Ric mostra il suo enorme talento vocale.
Le due canzoni inedite all’interno del risicatissimo set ricordano i primi Editors, e mentre Gallop riecheggia nelle sue liriche agrodolci e meditative, finisce uno dei concerti più intensi a cui abbia avuto l’onore di partecipare.
La ricerca sonora dei God is an Astronaut cambia completamente le carte in tavola, con chitarre che “cercano” i tappeti di synth in punta di piedi, liberandosi della tipica forma post rock “preludio-esplosione” e marcando, anche con linee melodiche vocali pesantemente processate dai computer, un passo avanti nella ricerca della band statunitense.
La conclusione del festival è invece affidata alle leggende giapponesi Mono, che del post rock rappresentano il lato più intimo ed espressionista. Tra atmosfere che è arduo non definire epiche, o talvolta drammatiche, confezionano un concerto roboante e monolitico in cui è difficile scomporre i pezzi, in cui i ragazzi del sol levante abbracciano con decisione il vento della musica da camera mentre il loro impeto sonoro conclude questo fantastico festival do it yourself di fine agosto.
Tirando le somme, il maggior pregio dell’ArcTanGent è stato la sua schiettezza e semplicità: a differenza delle grandi manifestazioni con folle oceaniche, in cui spesso parte del pubblico è presente “per essere presente”, si percepiva chiaramente come l’attenzione fosse focalizzata sulle performance delle band piuttosto che sull’area ristoro o l’outfit dei vicini di tenda.
Una bella situazione, sintetizzata meravigliosamente da Rory Friers, cantante degli ASIWYFA: “it’s great to have all the weird people into the same weird stuff as we are, all in the same place with all our weird friends in their weird bands too”.